Excerpt
Indice
Introduzione
1. Il linguaggio ed il discorso politico
1.1 Il linguaggio politico
1.2 Il discorso politico
1.3 Concetti politici
1.4 Opposizioni
1.5 Il potere costituente
1.6 Il linguaggio delle helping professions
1.7 Autorità, controllo e creatività
1.8 La lingua istituzionalizzata è una partita a scacchi
2. Dalle ideologie ai media » Pag. 25
2.1 Ideologie
2.2 Il contesto extralinguistico: morotese e dorotese
2.3 La crisi, le rivoluzioni ed i totalitarismi
2.4 Gli stili e la funzione retorica
2.5 Persuadere chi?
2.6 Posizionamenti
2.7 Media
3. Metafore e genitori » Pag. 43
3.1 La metafora
3.2 Il paradigma cognitivista e la metafora
3.3 Il frame
3.4 Soldi, verità ed accordi
3.5 L’11 settembre e la War On Terror
4. Aristotele e la prospettiva retorica
4.1 Retorica
4.2 L’atto oratorio
4.3 Le prove retoriche
Conclusioni
Bibliografia
Abstract (English
Introduzione
Lo studio del linguaggio politico come discorso risale agli anni ’60. Grazie soprattutto al lavoro del filosofo Michel Foucault, in quegli anni si iniziò ad utilizzare tale approccio per analizzare il linguaggio delle istituzioni e degli agenti politici. L’intera attività istituzionale cominciò quindi ad essere studiata cercandone finalità specifiche, quelle della ricerca del consenso e della gestione del potere. Del linguaggio politico non si studiarono più semplicemente le costruzioni semantiche o sintattiche, ma anche i simboli ed i riti. Da questo spunto, ebbero successivamente impulso gli approcci alla materia in senso linguistico e politologico.
Come spesso accade, alla conseguente fioritura di studi seguirono profonde divergenze fra gli studiosi. Secondo Giorgio Fedel [1999], nella letteratura specifica prevalgono due dimensioni. La prima, detta panpolitica, intende l’intero linguaggio naturale come interazione tra almeno due individui e quindi come politico: è la prospettiva del discorso politico come istituzione sociale, non discernibile dagli altri linguaggi, ed inteso come parte dei processi di potere, consenso e legittimazione propri della politica [Cedroni e Dell’Era, 2002]. L’altra dimensione, quella patologica, considera invece il discorso politico come semirazionale o irrazionale e orienta il proprio percorso di analisi sulla base della lontananza rispetto alla cosiddetta argomentazione razionale. Si tratta del linguaggio tipico dei regimi totalitari o di quello derivante dalle distorsioni comunicative evidenti in alcuni dei moderni regimi democratici. A tali due dimensioni, come sottolineano Lorella Cedroni e Tommaso Dell’Era, occorre aggiungerne una terza, quella del linguaggio politico come linguaggio settoriale, legato alla lingua comune e ad altri linguaggi speciali e contestuale ad un proprio ambito di pertinenza dai confini non sempre ben definibili.
Ci troviamo di fronte dunque a tre possibili alternative: una che elimina il proprio oggetto di studio, un’altra che vede il linguaggio politico come mancante delle essenziali funzioni linguistiche (siano esse la qualità, la chiarezza, la precisione…), ed infine un’ultima, per molti versi ormai antiquata, che prova a spiegare i meccanismi di intersezione tra linguaggio e politica nelle moderne società occidentali.
Appare opportuno in questo senso riorientare le ricerche in direzione multidisciplinare, ricercando le corrispondenze tra la dimensione linguistica e quella istituzionale, cercando di capire che tipo di codici prevalgono in questo particolare ambito della vita sociale e servendosi di diversi paradigmi di studio. È infatti ormai indubbio che tra la prassi politica ed il suo linguaggio esista una precisa corrispondenza, e che prassi e linguaggio si influenzano e si modificano vicendevolmente. La politica orienta gli attori nello scegliere il proprio linguaggio, e la lingua non si limita ad una mera funzione strumentale, bensì ad un’attiva opera di cambiamento e di modificazione della realtà.
Scopo di questo lavoro è quello di contribuire alle ricerche sul linguaggio e sul discorso politico con un’attenzione particolare ad una problematica specifica, quella retorica, intersezione ideale negli studi tra l’impostazione della scienza politica e quella della filosofia del linguaggio; ciò ha richiesto una selezione della letteratura che tenesse in conto soprattutto i discorsi ed i prodotti linguistici delle istituzioni e degli agenti politici, ma contemporaneamente anche i problemi posti dalle problematiche illustrate da Foucault e dalle riflessioni rispetto alla dimensione politica insita nel linguaggio stesso. Rispetto ai problemi propri della via retorica, anticipiamo qui un’intenzione di base, quella di esplorare la funzione persuasiva del linguaggio politico: prospettiva che rifiuta di scindere gli aspetti razionali e quelli irrazionali di un processo persuasivo e che cerca di far quadrare il cerchio tra emozione, logica, stile e verità. Per far ciò abbiamo pensato un percorso che partendo da un’ottica più teorica e ricca di complessi paradigmi interpretativi si confrontasse con il ricorso ad una sempre più feconda tradizione di studi aristotelici che vede nella teoria centrale della persuasione del filosofo di Stagira una pietra angolare per la comprensione dei fenomeni retorici.
Primo capitolo: Il linguaggio ed il discorso politico
«Every ideology is only the false mask for schemes in behalf of the strongest»
Chaim Perelman, The New Rethoric and Humanities, p. 143
«When I use a word, it means what I want it to mean, neither more nor less…
The question is who is to be the master, that’s all»
Lewis Carroll, Alice Through The Looking Glass, p. 190
1.1 Il linguaggio politico
Secondo i politologi Cedroni e Dell’Era [2002], i campi di analisi del linguaggio politico sono essenzialmente tre: il linguaggio della teoria politica, il linguaggio della ricerca politica ed il linguaggio della prassi politica. Secondo i due studiosi, il primo è il momento essenzialmente speculativo, di studio; il secondo è quello operativo, ed il terzo è quello maggiormente pratico, concreto.
Ciò che ci interessa principalmente in questo senso, non è tanto una distinzione, bensì al contrario un’attenzione a quello che accomuna questi linguaggi. Esiste, secondo i due studiosi, una struttura socialmente determinata, dipendente dai diversi contesti ideologici, culturali e storici che danno vita a «comportamenti linguistici altamente differenziati, utilizzati per il posizionamento dei partiti e dei leader o per attivare processi di identificazione e mobilitazione». Questa è un’idea importante, proprio perché è il primo elemento di legittimazione di uno studio in un ambito di ricerca contrassegnato da una così vasta mole di materiale da prendere in considerazione.
Paul E. Corcoran sostiene che «il linguaggio politico come paradigma in scienza politica è tutt’altro che chiaramente definito» [1990, p. 66]. È un’affermazione quasi unanimemente (e tacitamente) condivisa dagli studiosi consultati per questo lavoro. Sicuramente esiste un secondo elemento che funge da collante rispetto ai diversi campi proposti come elementi fondamentali dell’analisi, ed è la caratteristica destinazione pubblica del linguaggio, sia essa intesa come riguardante le idee sia i progetti o anche le semplici opinioni. Definire il concetto di linguaggio politico in realtà serve maggiormente a denotare una diversità esistente rispetto al discorso politico, anche se molti studiosi sembrano confondere i due concetti. È proprio per questo che all’interno del significato di discorso politico Cedroni e Dell’Era propongono una definizione del solo linguaggio politico, visto come «l’insieme di costruzioni linguistiche rappresentative o denotative, semantiche o connotative, pragmatiche o razionali» [2002, p. 56].
Sicuramente però, esistono altri elementi di interesse su questo stesso concetto. Il politologo americano Edelman si spinge ad affermare che «il linguaggio politico è la realtà politica» [1992, p. 98]. Con questo si vuole fare riferimento non solo ad un’idea di linguaggio come parte integrante e costituente del discorso politico, ma anche ad un altro problema: che tipo di esperienze ha l’opinione pubblica della politica? Escludendo infatti i cosiddetti addetti ai lavori, cioè coloro i quali «fanno» la politica, anche chiunque non si limiti soltanto alle dichiarazioni verbali dei politici, ma si informi e ottenga anche altri prodotti degli stessi (leggi o prodotti di altre istituzioni politiche, per esempio), sarà sempre caratterizzato da un’esperienza «sul linguaggio degli eventi politici, piuttosto che sugli eventi stessi» [ ibid.]. Ecco perché il linguaggio politico riveste una grande rilevanza per l’intera società: seguire la politica per un comune cittadino è un’esperienza linguistica, che spesso può comportare numerose difficoltà; a questo proposito si pensi ad esempio a quando si incontrano la politica ed il burocratese.
Cos’è invece il discorso politico, dunque?
1.2 Il discorso politico
Riprendendo il filosofo Michel Foucault, Chris Weedon definisce come discorso «i modi di costruzione della conoscenza insieme alle pratiche sociali, alle forme di soggettività e alle relazioni di potere inerenti a tali conoscenze, e alle relazioni tra loro. I discorsi sono più che dei semplici modi di pensare e di produrre significato. Costituiscono la natura del corpo, della mente (incosciente e cosciente) e della vita emozionale dei soggetti che cercano di governare» [Weedon, 1987, p. 108, trad. mia]
Qui c’è tutta la grande attenzione che Foucault rivolge alla storia, con un precipuo senso archeologico (o genealogico) [1969] di uno studio della produzione di conoscenza nel corso dei secoli; con ciò egli intende guardare alle continuità e alle discontinuità dell’epistéme prodotta nel tempo, laddove per epistéme intende il sistema di costruzione delle conoscenze che primariamente influenzano il pensiero durante ogni diverso periodo storico e ai contesti sociali nei quali alcuni comportamenti erano desiderabili o proibiti. Per il filosofo, conoscenza e potere sono inestricabilmente connessi, inscindibili. Sempre secondo l’interpretazione che Weedon dà di Foucault, il potere non è altro che «un controllo dinamico ed allo stesso tempo una mancanza di controllo tra il discorso ed i soggetti, costituiti dai discorsi, che sono di questi gli agenti. Il potere è esercitato attraverso i discorsi proprio con il loro costituire e governare i soggetti individuali» [p. 113, trad. e corsivo miei]. Alcuni discorsi avrebbero creato e definito i sistemi attualmente definibili come veri, che strutturano come noi definiamo ed organizziamo sia noi stessi che il mondo sociale, marginalizzando e soggiogandone altri di diversa origine ed impostazione, cui comunque sono permessi spazi di contestazione e sfida verso lo status quo. Foucault spiega tutto questo con le proprie ricerche focalizzate sul come la sessualità, le punizioni e la follia siano state viste nel corso dei secoli; la formazione delle identità e delle pratiche sociali, in definitiva, sono correlate storicamente a dei discorsi specifici.
Un concetto come quello di campo discorsivo, secondo il quale esisterebbe, per esempio, un ambito discorsivo proprio della legge o della famiglia, serve a spiegare come possono esistere all’interno di uno stesso ambito anche una serie di discorsi in contraddizione ed in competizione tra loro, che in maniera diversa contribuiscono all’organizzazione sociale e a dare un senso stesso ai processi sociali. La volontà di verità è un sistema di esclusione che forgia il discorso e che esercita una pressione rispetto ad altri discorsi. «Cos’è in gioco nella volontà di verità, nella volontà di edificare un discorso come vero, se non il potere ed il desiderio?» [Foucault, 1984, p. 113-4, trad. mia]
Accertato dunque che nello stesso complesso sociale troviamo un discorso dominante ed altri non dominanti e che producono conoscenza, quello che rimane da chiederci è il perché alcune voci, riescono ad essere «udite» mentre altre no, chi ne beneficia e come. Il filosofo suggerisce dunque di orientare la ricerca proprio verso lo studio della concreta traduzione o riproduzione degli ordini presenti nel discorso politico delle pratiche istituzionali sovrastanti la società.
Il livello di analisi proposto è proprio quello delle relazioni che definiscono il discorso, dunque, e non le semplici analisi lessicali, grammaticali o semantiche. La chiave per comprendere il concetto è l’influenza che l’enunciatore ha nei confronti dell’ascoltatore, identificando come evento in sé il discorso stesso. Come suggerisce Francesca Santulli [2005], ciò che preme a Foucault è la caratteristica interazione all’interno dell’evento discorsivo e del manifestarsi di tutti gli elementi che lo compongono. Il discorso è la lingua utilizzata in situazioni concrete ed utilizzata per arrivare a determinati scopi, essendo al tempo stesso sia struttura che processo, analizzabile sia nell’analisi dei propri enunciati che delle proprie funzioni. Il discorso diventa, come si è già visto, una pratica sociale.
1.3 Concetti politici
Come si creano nella mente umana i concetti politici? Lev Semenovich Vygotsky, studioso russo nato nel 1896, tra i più influenti psicologi del XX secolo, dedicò i suoi maggiori lavori allo studio della relazione tra lo sviluppo del linguaggio e quello del pensiero, ed in particolare alla relazione esistente nel formulare un discorso (sia esteriormente sia interiormente), lo svilupparsi dei concetti mentali e la metacognizione individuale, cioè la capacità dell’individuo di riflettere sul proprio modo di pensare e sulle proprie percezioni, prevedendo le proprie reazioni o quelle altrui, secondo le diverse circostanze. Secondo la prospettiva di Vygotsky [1934], un concetto di qualsiasi tipo può diventare un elemento linguistico utilizzabile con consapevolezza e controllabile solo quando è parte di un sistema in cui ad un concetto di ordine superiore ne corrispondono altri di ordine inferiore. Questi concetti nascono con la socializzazione all’interno di una comunità, che perpetua le proprie modalità di trasmissione e costruzione dei significati; ciò vuol dire, in realtà, che non esiste nulla di inevitabile o innato nella trasmissione ed acquisizione del linguaggio in società, ma che tutto viene determinato dal ruolo della scuola e dell’insegnamento in generale.
Il problema posto dalla maniera in cui un concetto viene effettivamente messo in relazione ad altri per essere recepito presenta comunque questa fondamentale caratteristica di cui si è già parlato: la tendenza alla gerarchizzazione. Lo studioso parla in questo senso di relazioni di iponimia ed iperonimia, a proposito del rapporto che si stabilisce tra alcuni elementi dalla diversa ampiezza semantica in uno stesso schema mentale, la cui chiarezza o opacità risulterà determinante nella costruzione dei concetti propriamente politici.
Risulta al riguardo particolarmente interessante il lavoro del professore di pedagogia, filosofo e politologo Trevor Pateman [1975] proprio per i legami che stabilisce tra questi studi ed i problemi sull’analisi della creazione dei concetti in questo ambito. Pateman ci ricorda come i linguisti generalmente concordino su alcune caratteristiche del linguaggio naturale, che non è un sistema ordinato, tutt’altro. Per John Lyons, il vocabolario del linguaggio naturale tende ad avere molti gap, asimmetrie e indeterminatezze, e rimane lontano dunque da «una tassonomia scientifica e dalle sue caratteristiche di comprensibilità e sistematicità» [1968, p. 456, trad. mia]. Si pensi soprattutto alle riflessioni di Ludwig Wittgenstein [1958], in questo senso.
Secondo Pateman dunque, i vocaboli politici soffrono in maniera particolare di una disorganizzazione gerarchica e sistematica riguardante gli schemi linguistici delle persone, che porta i concetti stessi a rimanere parzialmente a-concettuali, e comporta una conseguente diminuzione della possibilità da parte degli stessi individui di comprendere i discorsi che fanno uso di questo tipo di vocaboli. L’esempio di Pateman è illuminante. Egli utilizza vocaboli quali anarchia o anarchismo, definibili come vocaboli attinenti all’idea di costruire una società senza governo; il diagramma ad albero che comprenderà alcuni termini quali anarchia, governo, un vocabolo di più ampio respiro come società e gli iponimi del vocabolo governo (per esempio monarchia, democrazia, aristocrazia), si presenta come un diagramma (vedi fig. 1) in cui solo alcuni vocaboli sembrano avere una base concreta (anche per un problema di referenza nella realtà): saranno questi gli iponimi della parola governo; i vocaboli ad un più alto livello sembrano invece rimanere più astratti. Va da sé che vocaboli come monarchia, democrazia ed aristocrazia che secondo Vygotsky sono definibili come complessi (vocaboli per i quali non esiste un set finito di caratteristiche sufficienti o necessarie, pur essendovi comunque un legame tra le varie definizioni), rappresentano un classico esempio di somiglianza di famiglia alla Wittgenstein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figura 1 [Pateman, 1975, p. 131]
Così, il termine società ed il termine governo secondo Pateman non sono effettivamente legati tra loro nelle menti dei parlanti, mentre lo sarebbero governo ed i suoi iponimi, essendo ad un livello più semplice da comprendere . La parola governo diventa dunque una sorta di nome famigliare per un gruppo di altri vocaboli e non un’idea compresa in un orizzonte concettuale più esteso. Maggiori problemi presenta un termine come anarchia; non essendo infatti possibile riferirsi ad alcun esempio concreto di applicazione politica del concetto, la sua distanza rispetto al termine società appare allo studioso abbastanza grave; l’unico vero aggancio può avvenire solo rispetto ai suoi co-iponimi quali monarchia, aristocrazia e democrazia.
In sostanza il discorso di Pateman si rivolge polemicamente allo strutturalismo saussuriano; secondo lo studioso, questi tipi di vocaboli non si possono capire adeguatamente con la semplice opposizione di termini ad uno stesso livello.
Probabilmente è più immediato trasporre il problema secondo schemi di studio propri della psicologia sociale. Potremmo dire infatti che il processo di ancoraggio del termine anarchia, cioè «l’integrazione cognitiva (funzionale) dell’oggetto rappresentato nel sistema di pensiero preesistente» [Jodelet, 1984] sembra soffrire per una mancanza di senso e comunicabilità già propri della categoria delle rappresentazioni politiche (i problemi di distanza dal vocabolo fondante dello schema, società). Questo probabilmente dipende anche da alcuni caratteri tipici della stessa modernità. Serge Moscovici parla del fatto che in una società aperta e pluralista gli universali simbolici sono molteplici e spesso contraddittori. I media hanno sicuramente contribuito anch’essi ad accelerare il massiccio processo di circolazione di informazioni, idee e concetti non facenti parte del cosiddetto «senso comune» [1988]. Secondo Pateman in questo senso i media sono imputabili dell’abuso di parole ad un livello talvolta eccessivamente astratto e talvolta eccessivamente concreto. Mancherebbe quindi il livello intermedio. Progresso, reazione, ordine, disordine sono alcuni esempi di termini astratti utilizzati per spiegare i fenomeni politici, che andrebbero invece più adeguatamente spiegati con concetti di tipo intermedio, come classe, status, ceto: termini in grado di rappresentare le aree più controverse del dibattito politico e quelle meno evidenziabili a livello propagandistico.
Quali, dunque, le conseguenze di tutto questo per i destinatari del discorso politico? Sicuramente, come si è già detto, una certa difficoltà ad analizzare i fenomeni politici, a categorizzarli, a capirli. Ma ci sarebbe anche una generalizzata tendenza alla nascita di ideologie spontanee, che sarebbero il risultato di una riflessione piuttosto immediata delle circostanze ordinarie della vita del singolo individuo, che tende a non trascendere le proprie esperienze e a prendere le apparenze della realtà come realtà stessa, non filtrandola, e le contingenze materiali come teoria esplicativa della stessa. Non si farebbe altro così che reificare l’esistente rinunciando a costruire delle vere e proprie teorie politiche o delle analisi storiche condivisibili o accurate: il presente diventerebbe il frutto inevitabile di un processo immutabile, il cambiamento sociale non dipenderebbe dall’agire umano, fosse esso collettivo o individuale e i bisogni e gli interessi che potrebbero stimolare l’azione sociale sarebbero repressi o verrebbero sublimati. In definitiva, gli individui troverebbero difficoltà a diventare dei veri e propri soggetti politici, anziché meri oggetti. È questo il caso tipico di alcune teorie sull’ordine sociale di tipo religioso o tecnocratico, secondo lo studioso. Ed è da notare inoltre come idee come quelle appena esposte fanno spesso da base teorica per quella visione patologica accennata nell’introduzione. Le fallacie, le anomalie, addirittura le ampollosità e la pregnanza ideologica dei discorsi politici sarebbero il segnale delle loro ineliminabili carenze teoriche e del vizio dell’imporre degli schemi preconcetti della realtà ai cittadini. La sterilità di approcci come quello patologico è evidente: è infatti impossibile valutare la fallacia o meno del linguaggio politico semplicemente perché in realtà non esiste un modello di linguaggio ideale cui riferirsi. Inoltre, cercare di evidenziare le caratteristiche negative dell’oggetto in questione non serve a spiegare efficacemente le differenze che intercorrono tra politico e politico e tra sistemi diversi.
Comunque, riflessioni come quella appena esposta che non degenerano in considerazioni apocalittiche sulla natura del linguaggio politico, sono ricche di potenzialità. Si potrebbe per esempio prendere in considerazione lo studio da un lato dei concetti mentali (ed il loro funzionamento) e dall’altro lo studio dell’etimologia del vocabolario politico, scoprendone differenze, affinità, incompatibilità. Inoltre, si ricordi che la prospettiva di Vygotsky è legata alla scuola storico-culturale e dunque costituisce un approccio specifico al problema, ma non l’unico.
Si pensi per esempio all’importanza data da Jürgen Habermas, nella teoria detta dell’agire comunicativo [1986], del problema etimologico dei termini della sfera politica. Il filosofo suggerisce infatti come il livello di trasparenza del processo di discussione democratica dipenda anche dalla condivisione dei diversi significati dati dai astanti politici alle parole utilizzate. Così facendo, il filosofo tocca un tasto dolente, se consideriamo non solo la naturale diversità di interpretazione e significato dati da ogni parlante ad ogni termine (in questo senso, si rimanda anche alla trattazione del rapporto tra linguaggio ed ideologie nel prossimo capitolo), ma anche al fatto che non esistendo una dimensione cristallizzata ed atemporale della lingua, trovare un accordo sul significato attribuito alle diverse parole è un’ardua impresa.
1.4 Opposizioni
Sempre a proposito dell’opposizione tra termini come quella proposta nello schema di Pateman, possiamo citare Richard Jackson [2005] che ricorda come diventi assodato, con i primi antropologi e linguisti, che il linguaggio abbia una struttura essenzialmente binaria, che fa sì che ogni nome, aggettivo o verbo abbia un proprio opposto. Questo tipo di costruzione porta necessariamente anche ad una «svalutazione di uno dei due termini in favore dell’altro» [Llorente, 2002, trad. mia]. Amore / odio, buono / cattivo, moderato / radicale. Il linguaggio trova un esempio concreto della propria non neutralità e della propria influenza sulle strutture cognitive a partire dal vocabolario e dagli usi che se ne fanno nell’influenzare le emozioni, le percezioni, le conoscenze. L’opposizione saussuriana non sfugge a questa valutazione di positività o negatività. Il 12 settembre 2001 il Corriere della sera titolava «Attacco all’America e alla civiltà», anticipando la retorica presidenziale statunitense sullo scontro barbari / civili, insito nell’idea di scontro nell’opposizione civiltà/inciviltà. È ovviamente anche il caso di governo / non governo dello schema precedente, molto semplicemente. Positivo o negativo, a seconda del punto di vista.
Secondo Edelman [1984], ancor più tipico del linguaggio utilizzato dalla politica è lo sfruttare i termini che determinano opposizione piuttosto che unione. Una parola come tirannia, suggerisce lo studioso, non vuole semplicemente descrivere qualcosa, ma opporsi (o fare opporre qualcuno) rispetto a qualcos’altro, cioè alla parola autorità. Nel caso invece di alcuni vocaboli della prassi politica definiti dallo studioso come pubblici, il discorso è ancora più complesso. Sono questi dei termini certamente politici, ma più velatamente. Si differenziano infatti dagli ultimi perché mentre questi sono funzionali alla creazione del consenso, quelli pubblici al contrario devono mascherare la propria funzione politica. Un esempio è l’utilizzo del termine aiuto. Questo termine non viene utilizzato alla stessa maniera se rivolto alle élite economiche o a chi appartiene agli strati sociali più in basso della sfera sociale. Gli aiuti ai ceti medioalti ed alti infatti non sono mai presentati all’opinione pubblica come aiuti veri e propri, ma come stanziamenti atti al conseguimento di un obiettivo: la produzione agricola, il miglioramento dei trasporti, l’incremento del volume commerciale, ecc… Non si indicano come beneficiari di un aiuto coloro per i quali questi non sono un mezzo per un obiettivo di natura diversa, ma un fine vero e proprio. Sarebbe certamente un azzardo in termini di consenso politico rivelare come la spesa governativa sia spesso un semplice incentivo a chi di questo non avrebbe bisogno per il proprio sostentamento. Se i destinatari di una certa azione di governo sono invece classi basse o mediobasse della scala sociale, gli aiuti di carattere economico o assistenziale sono sempre sottolineati come tali. Una riprova di quest’osservazione è data dal fatto che con l’apparire di questo tipo di aiuto si affacciano sulla scena anche nuovi attori e nuovi ruoli sociali. I beneficiari non sono messi a fuoco, ma rimangono astratti in quanto categoria sociale le cui difficoltà vengono anche dalla gestione della cosa pubblica. Avremo così i poveri, i nullatenenti, coloro che non arrivano a fine mese che diventeranno coloro i quali non pagheranno una determinata tassa, per esempio; sono coloro che ragionevolmente hanno bisogno di aiuto, un aiuto che sia spiegabile all’opinione pubblica, ma la cui entità sarà ragionevole sia in termini monetari che di status sociale o di autonomia. È una caratteristica conservatrice delle istituzioni preposte a gestire questo tipo di fondi quella di evidenziare sempre i confini ed i limiti di aiuto fornito ai beneficiari; l’intento di conservazione è evidente e spiegato tramite l’ausilio di termini detti, appunto, pubblici. L’eterogeneità dell’uso di questi termini è chiaramente dettata dalla funzione politica che se ne fa.
1.5 Il potere costituente
Alla luce di queste prime considerazioni, così si può dunque dire sulla materia, data la propria eterogeneità?
Secondo Dell’Era e Cedroni [2002], data l’alta incidenza del discorso politico sulla realtà, il suo fondamentale intento è pragmatico nelle intenzioni persuasive, ed in attesa di una qualche azione conseguente (in senso perlocutivo). Dunque, anche ammettendo una certa fallacia propria del linguaggio politico in sé derivante dai concetti stessi di cui si farebbe portatore (specie a livello di teoria politica), ne rimane comunque questa forza discorsiva. Edelman [1976] sostiene che aumentando sempre più la distanza tra leadership e cittadini nelle società contemporanee, aumenta maggiormente la necessità di costruire i significati più che di tradurli semplicemente, come invece volevano dimostrare le pionieristiche ricerche di Harold Lasswell e Nathan Leites negli anni ’50. La forza costituente del linguaggio politico sta nella sua capacità di rendere credibili e concepibili alcune rappresentazioni provenienti dalla sfera politica, in maniera complessa e non unidirezionale. Pateman sottolinea come il ruolo del singolo politico abbia senza dubbio una funzione positiva nel processo di formazione della lingua della politica, ma non necessariamente positivo anche nella creazione nelle menti dei singoli dei concetti di cui sopra, dato che ogni agente politico sembra interessato più che a fornire informazioni sul sistema stesso, a darne sulla propria posizione al suo interno: ognuno pensa alla propria visibilità, insomma.
Anche per questi motivi, si cercherà adesso di allargare il discorso in senso come si è detto panpolitico perché una prospettiva di questo tipo, se non abusata, serve per potere operare una discussione completa sulla terminologia, sulla sintassi e sulle strategie argomentative all’interno del discorso politico. Si cercherà così di integrare una componente di linguistica critica e di analisi critica del discorso agli studi presi in esame, per focalizzare l’analisi sulla sua pertinenza rispetto all’ideologia, al potere e alla realtà, mettendo in luce come l’analisi del discorso politico sia pertinente rispetto a tutto ciò ed anche sul come esso ricostruisca e modifichi la realtà stessa.
1.6 Il linguaggio delle helping professions
Secondo Edelman [1984], il linguaggio politico è anche «lo strumento attraverso cui si esprime una relazione di potere» [ivi, p. 45, trad. mia] . Si è già accennato ai suoi studi sul linguaggio politico, che possono essere tacciati di panpoliticismo per molte considerazioni, ma che presentano numerosi punti di interesse per le idee proposte. Fondamentalmente, secondo questo tipo di prospettiva, l’azione ed il linguaggio si determinano a vicenda ed il linguaggio è sempre intrinseco rispetto all’agire sociale; esso non è mai neutro. Come è già stato affermato precedentemente, considerandolo un semplice strumento, ne nascondiamo l’importanza strategica nel creare relazioni sociali, nell’affinare i ruoli e nel contribuire alla costruzione del sé. Uno degli studi condotti da Edelman è quello sulle professioni di servizio (helping professions) usate come indicatori per evidenziare in quale modo il loro uso dei termini linguistici serve a categorizzare i «clienti» e a giustificare alcune restrizioni morali e fisiche, attraverso un utilizzo, definibile come politico, del linguaggio. Un termine, una metafora o una forma sintattica dalle connotazioni politiche possono infatti evocare o giustificare una gerarchia di potere nella persona che le usa e nella persona (o nel gruppo di persone) che la recepisce.
È un paragone interessante in tal senso quello esistente tra il comportamento di un qualsiasi governo di un paese, che rifiuta di trattare con chiunque contesti il sistema stesso facendo uso di strumenti di lotta illegali, nocivi, violenti, e il comportamento dello staff ospedaliero nei confronti di pazienti affetti da alcune categorie di disturbi mentali, che per motivi terapeutici non sono assecondati nel rinforzare i comportamenti devianti, e sono contraddetti o ignorati da medici ed infermieri. Tutto questo ovviamente secondo alcune decisioni terapeutiche ineccepibili, con il risultato aggiunto però di rafforzare le relazioni di potere nella relazione tra i pazienti e lo staff della struttura medica. Anche in classe avviene la stessa cosa: si ignorano o si puniscono alcuni studenti con l’intento di non assecondare il loro comportamento quando deviante. Il linguaggio professionale in questi esempi rinforza le convinzioni sociali sul valore sociale di alcune categorie di persone, su chi è ritenuto meritevole e chi no dalle istituzioni, e dunque viene premiato o punito; Edelman auspica che grazie a questi studi si possa arrivare a ragionare sugli status, sulle ricompense, su come siano influenzate la distribuzione delle ricchezze e della povertà, sui rapporti tra i sessi, sul conformismo e l’anticonformismo, e così via.
Se, dunque, è possibile vedere sia le pratiche sociali che quelle governative come pratiche che possono essere entrambe viste come politiche, pur se di specie diversa, conseguentemente sembra sia possibile vedere anche gli atti politici come atti terapeutici. L’autore riporta gli esperimenti condotti negli anni ’60 dal Law Enforcement Assistance Administration che, studiando in quale modo alcune forme di protesta politica estrema come l’esposizione di comportamenti rabbiosi o depressi fossero non distanti da quelli di alcuni malati di mente, ipotizzò una risposta non solamente politica quanto in realtà clinica. Una riprova di questo parallelo tra contesti diversi, è la trasformazione di alcuni soggetti in oppositori ed altri in alleati attraverso l’uso che facciamo di un concetto di derivazione politica in un contesto non politico; si pensi ad esempio alla possibilità di descrivere la gestione dei rapporti di lavoro come una tirannia.
Non è difficile trovare delle imprecisioni, delle debolezze o dei punti di discussione critica sul lavoro di uno studioso come Edelman, specialmente data l’ampiezza dell’argomento e l’utilità di tracciare in questo senso i confini del linguaggio politico (o di non tracciarli, probabilmente); sta di fatto che esso rappresenta l’esempio di un filone di ricerca che ha avuto (e continua ad avere) una larga fortuna, soprattutto tra gli scienziati politici nel loro approccio allo studio del discorso e del linguaggio politico. Probabilmente identificare una particolare forma-funzione (che Cedroni e Dell’Era intendono come l’identificazione del modo in cui il discorso politico provoca degli effetti) che lo spieghi come attinente non solo alla sfera politica in senso stretto, serve ad evidenziare i motivi stessi che ci spingono ad interessarci a esso, pur se con una prospettiva che studia solo parte di ciò che interessa; di ciò si riparlerà nel prossimo capitolo.
1.7 Autorità, controllo e creatività
Continuiamo a sfruttare l’idea panpolitica e la prospettiva politologica per presentare altre interessanti riflessioni sulla lingua, sui concetti e sulla società contemporanea in generale.
Dalle idee proposte al paragrafo precedente, sembra evidente dover passare al problema del rapporto tra il discorso politico e l’autorità. La nostra intenzione è di affrontare il problema caso per caso, ma tuttavia conviene accennare che la predisposizione a rispettare le figure di autorità è naturale; per quanto ci riguarda si pensi all’attribuzione di potere conferita da Aristotele alla figura del retore.
Secondo lo psicologo americano Robert Cialdini [1984], la nostra abitudine all’autorità dipende dall’organizzazione della società umana, talmente dipendente dalla presenza di un’autorità al proprio interno da garantire una grande forza persuasiva a chi di potere materiale già dispone. Essa è un prerequisito della vita sociale, una condizione necessaria che come estremo opposto trova uno stato di natura di tipo hobbesiano, del «tutti contro tutti», per intenderci. È un’abitudine, questa all’obbedienza, legata ai principali momenti di apprendimento infantile ed ai rapporti in età adulta. Chiaramente nessuno studioso potrebbe negare l’esistenza di un meccanismo di convenienza al rispettare le figure di autorità: conformarsi, seguire i dettami dell’autorità conviene sempre, ma appunto, è anche una risposta quasi fisiologica da parte dell’agente sociale. L’autorità ha un certo «scatto naturale» in più nel riuscire a persuadere, dunque.
Per affrontare un'altra problematica connessa con i problemi di autorità, il politologo William E. Connolly [1984] va oltre nel radicare l’importanza della terminologia politica nella società. Suggerisce al riguardo che la somiglianza di famiglia esistente tra alcuni termini che rientrano in un immaginario vocabolario del lessico politico (per esempio: persuasione, coercizione, forza ecc…) sia diversa da società a società. Una concezione dell’individuo come agente capace di agire autonomamente, in maniera autocontrollata e coerente e degno di essere trattato come agente responsabile, è generalmente tipica di una società in cui è stato raggiunto un livello di condivisione valoriale tale che il linguaggio delle relazioni sociali esprimerà concetti più profondi, specificando in maniera più particolareggiata determinati contesti e differenziando in maniera più complessa relazioni e azioni che raggiungono certi standard rispetto invece ad altre società che non lo fanno. Le relazioni di differenziazione sociale che inibiscono la capacità di esprimere giudizi autonomi da parte dei singoli o addirittura che tendono a limitare la capacità di agire, saranno distinte da quelle che invece la incoraggiano. In altre parole, lo studioso cerca di avanzare una spiegazione del fatto che in una società in cui sono tracciabili differenze tra ciò che consideriamo una minaccia o un’offerta, un tentativo di persuasione o una manipolazione, allora lì riusciamo ad articolare in maniera più complessa ed articolata la concezione del nostro sé e della responsabilità del nostro agire sociale.
Il linguaggio del potere presenta dunque indubbiamente più di un contesto d’uso in questo senso, ma avrebbe alcune caratteristiche basilari. Come abbiamo visto prima con Edelman, anche secondo Connelly chi esercita un potere limita o impedisce le scelte o le azioni di chi quel potere subisce. Non si tratta, ovviamente, di una prospettiva apocalittica sull’argomento, ma di una riflessione ragionata proprio su quei concetti di autorità già citati. Le connessioni tra le istituzioni di potere, le agenzie, le responsabilità e gli agenti sociali, non indicano che non esistono giustificazioni possibili alle limitazioni in questione, ma inducono a una considerazione più fine, e cioè che il comportamento del singolo nel trattare gli altri agenti sociali comporta una presunzione che si tradurrà nella grammatica del potere (non necessariamente linguistica, bensì discorsiva ), proprio nella presunzione di trattare con altri agenti responsabili.
Così come già suggerito anche da altri studiosi, anche secondo questo autore il potere del discorso politico, che abbiamo definito come costituente, è evidente nel passaggio verso una sempre maggiore intersezione tra i poteri, le agenzie, le istituzioni e verso una sempre maggiore creatività linguistica, oltre che teorica. È interessante notare come ad una necessità politico-istituzionale ne sopraggiunge una linguistica: quote rosa, affermative actions, Partito democratico, sono costruzioni linguistiche introdotte da chi detiene parti del potere all’interno di un quadro sociopolitico di una società complessa in mutamento. Si rimanda ai prossimi capitoli per un’analisi di alcune caratteristiche del dopo 11 settembre in ambito linguistico, ma alcuni riferimenti sempre inerenti all’analisi dell’evoluzione della cosiddetta War on Terror possono essere utili. Secondo Jackson [2005], in un crescendo di inventività linguistica, due saranno le caratteristiche dominanti del discorso politico dopo l’attentato alle Twin Towers. La prima è l’alta riflessività. La Guerra al terrore ha implicato l’introduzione di alcuni accorgimenti linguistici riguardanti l’uso di alcuni termini. La guerra, per esempio, diventa una guerra al terrore perché non è una guerra «classica» in senso territoriale e diplomatico; e ancora, si è creata una nuova nozione, quella di civile combattente, per poter trovare uno status giuridico nuovo ai prigionieri militari presunti terroristi. Questo perché condurre una guerra contro il terrore significa condurre una guerra contro una tattica, contro una strategia violenta, quella di Al-Qaeda e dei suoi sostenitori, piuttosto che contro uno stato come in passato. E ciò spiega anche la necessità di affiancare ai nuovi microgruppi terroristici sparsi in varie regioni e stati del mondo anche una categoria di nemici storici della politica estera americana: gli stati cosiddetti canaglia. Il discorso politico su questo argomento dunque non è mai stato statico, piuttosto è sempre stato in fase di reinvenzione ed evoluzione, proprio per fronteggiare quelle instabilità e contraddizioni che necessariamente incontra.
Seconda caratteristica fondamentale sarà l’ opacità della lingua. Questa caratteristica fa sì che non si arrivi mai ad una completa definizione o spiegazione di molti termini, che spesso devono essere assunti o dedotti dal contesto. Come abbiamo già visto in Pateman [1975], altri studiosi suggeriscono che sia un problema di astrattezza di alcuni termini, come peraltro suggerisce anche Suman Gupta [2001]. Nel caso della guerra al terrore l’esempio più facile è quello dei termini bene e male: è difficile da osservatori neutrali conciliare con l’idea di bene le invasioni militari, le torture ai prigionieri politici. Eppure sono termini usati di continuo dalla classe politica (americana, soprattutto). Lo stesso si potrà dire dei termini vittoria, civilizzazione, libertà, da cui alcuni importanti fraintendimenti riguardo le conseguenze degli attacchi in Afghanistan ed Iraq negli ultimi anni e le critiche alle probabilmente troppo precipitose dichiarazioni di vittoria nella seconda Guerra del golfo.
[...]
- Quote paper
- Fabrizio Colimberti (Author), 2007, Dalle "convergenze parallele" alla Guerra al terrore, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463631
Publish now - it's free



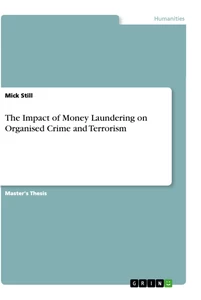
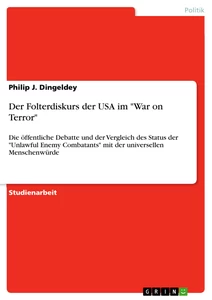
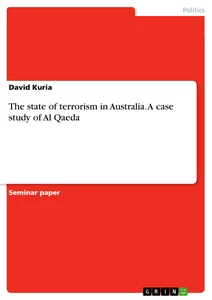


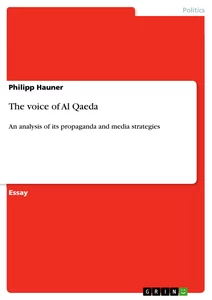
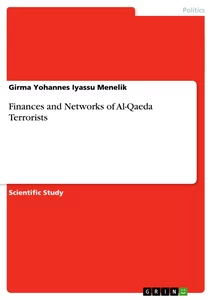

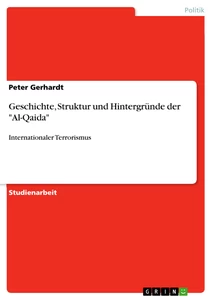




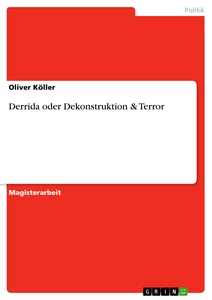
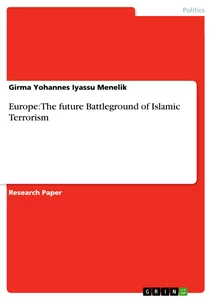




Comments