Excerpt
Indice
Introduzione
1. Possibilità e limiti traduttivi
La traduzione: quali significati nel mondo occidentale ?
Il problema e il senso della traduzione
Approcci traduttivi per il teatro greco
2. Pasolini traduttore di Eschilo
L ’ Orestiade : l’importanza del contesto
La scommessa di Pasolini
Un’analisi: la traduzione delle Eumenidi
3. Conclusioni: un incontro trasformazionale?
Bibliografia
Wie der Quell aus verborgenen Tiefen,
So des Sängers Lied aus dem Innern schallt
Und wicket der dunkeln Gefühle Gewalt
Die im Herzen wunderbar schliefen. [1]
FRIEDRICH SCHILLER
Introduzione
Questo libro trova il suo fulcro intorno a un problema: il linguaggio umano, la letteratura, il testo poetico nella sua complessa risolvibilità circa il rapporto di traduzione, in questo caso tra classici e moderni. Partendo da ciò, il mio lavoro comparativo si concentra nello specifico sulla traduzione da parte del poeta Pier Paolo Pasolini (1922-1975), uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano, di un’opera della letteratura greca di Eschilo (525 - 456 a.C.), il padre della tragedia occidentale. Va da sé che l’incontro dialettico - e preciserei “trasformazionale” - tra due importanti autori attraverso un’opera letteraria, possa suscitare un interesse degno di essere approfondito, con l’intento di fare chiarezza a riguardo[2].
Il saggio è diviso in due parti ben separate, dunque, per chi preferisse addentrarsi nel cuore del discorso, consiglierei di leggere direttamente il secondo capitolo. Il primo capitolo, infatti, mira ad offrire una sintesi generale dei ragionamenti su i limiti e le possibilità della traduzione, con l’intento di fornire delle coordinate sul significato del tradurre nel mondo occidentale, e in particolare sugli approcci traduttivi nei confronti dei classici del teatro greco; il secondo capitolo mette a fuoco, invece, la realizzazione dell’ Orestiade [3] di Pasolini, la scommessa della linea pasoliniana e le rese traduttive delle Εὐμενίδες (Eumenídes) di Eschilo, terzo momento della trilogia, portata in scena per la prima volta nel lontano 458 a.C. nel contesto democratico della polis ateniese[4].
Ci si può legittimamente chiedere se la tragedia portata in scena nel 1960 al teatro di Siracusa (per l’INDA[5] ) col nome di Eumenidi, così come l’intera trilogia, possa essere ancora la stessa opera dell’autore greco, o meglio - se non la stessa - un’opera che seppure trasposta in altra lingua ed epoca, in maniera originale e ricreativa, sia ascrivibile all’autorialità eschilea. Nel capitoletto finale sono presenti le conclusioni riguardo al dilemma da cui prende avvio questo lavoro.
1. Possibilità e limiti traduttivi
Muoversi tra le lingue, tradurre, sia pure in modo limitato, parziale, significa percepire la propensione quasi vertiginosa dello spirito umano verso la libertà.
GEORGE STEINER
La traduzione: quali significati nel mondo occidentale ?
Per potere attraversare il complesso ragionamento sulle possibilità e i limiti della traduzione, e nello specifico della traduzione ad opera di Pier Paolo Pasolini dell’ Orestea di Eschilo, sarebbe proficuo e opportuno tentare di fornire in primis delle definizioni dei significati di “tradurre” nel mondo occidentale, per potere in seguito individuare il senso della sua esistenza. Per non rimanere invischiati in ardue seppure interessanti elucubrazioni in senso astratto, mi pare preferibile non limitarsi ad un significato univoco del termine, che non può che essere troppo generico o tautologico e quindi sempre sfuggente in una “teoria della traduzione”[6], rispetto ai significati plurimi che il tradurre e la traduzione possono assumere nell’empiricità e nella concretezza di un esercizio o di un atto traduttivi.
Infatti, solo dalla seconda meta del Novecento si iniziò a discutere di una possibile “scienza della traduzione” - in tedesco Übersetzungwissenschaft, in francese traductologie [7], in inglese Translation Studies - un campo di studio «con antenati illustri da Cicerone a Lutero, e, più vicini a noi, Goethe, Humboldt e Schleiermacher, una disciplina o un'area disciplinare che avrebbe, se lo volesse, anche un patrono celeste in san Gerolamo, autore, oltre che della Vulgata, dell'epistola a Pammachio De optimo genere interpretandi »[8]. Innanzi tutto, è curioso ed emblematico ricordare che, paradossalmente, i termini per “tradurre” nelle lingue romanze pare derivino proprio da una sbagliata interpretazione, dal termine latino traducĕre (composto di trans «oltre» e ducĕre «portare»). Al XV secolo risalirebbe l’errore di comprensione di una frase delle Noctes Atticae (1, 18) di Aulo Gelio da parte di Leonardo Bruni[9], che interpretò traductum - inteso nel testo come “trapiantato/trasposto” dal greco al latino - nel senso odierno di “tradotto”[10].
A partire da questa svista il termine ha conosciuto, attraverso varie vicissitudini, una fortuna impensabile, non solo nell’italiano, nel quale soppiantò altre potenziali espressioni utilizzate sino all'inizio del Novecento - quali “recare in volgare”, “ritrarre in volgare”, “volgarizzare” - ma perfino espandendosi nelle altre lingue neolatine (port. traduzir, sp. traducir, cat. traduir, fr. traduire, rum. traduce). L’originale latino ha il significato in realtà di “portare a”, “trasportare”, tuttavia analizzando il significato etimologico di “tradurre” nelle altre lingue indoeuropee (ing. to translate [11], ted. übersetzen/übertragen, russo perevodit’) risulta evidente, infatti, come sia sempre presente una sfumatura di “passaggio”, di “traporto”, che avviene da un versante ad un altro. In latino esisteva una molteplicità di forme verbali specifiche per indicare il tradurre per iscritto, quali vortere o vertere (coi derivati convertere e transvertere), imitari, exprimere, reddere, mutare, transferre, interpretari. Il “problema” della traduzione scritta risultava molto importante per i Latini, come si evince dalla quantità di espressioni per indicare il “tradurre”, proprio per il fatto che dovessero rapportarsi, in primis, all'eredità culturale e letteraria dei Greci (la prima opera della letteratura latina si ricorderà essere l’ Odusia di Livio Andronico, una “traduzione libera” dell’ Odissea omerica).
Questi ultimi, invece, erano «poco aperti con pochissime eccezioni al plurilinguismo e al riconoscimento delle lingue “barbare”, giudicate inferiori e inintelligibili», e «vennero dapprima e più intensamente in contatto orale con lingue di struttura tanto diverse»[12]. Il termine greco utilizzato era infatti ἑρμηνεύειν, legato maggiormente all’oralità, il cui significato assai sfaccettato e denso può essere suddiviso in tre direzioni: «affermare, esprimere», «interpretare, spiegare», «tradurre, fare da interprete»[13]. Esso fu probabilmente attinto da una lingua dell’Asia Minore e «resta di etimo misterioso anche nei suoi collegamenti col nome di Hermes, Ermete, in cui qualcuno volle vedere il dio interprete, mediatore»[14]. Mentre il termine ἑρμηνεύς è legato a un senso di penetrazione profonda dell’ignoto - sottolinea Gianfranco Folena - il latino interpres, -etis è riconducibile a una sfera più pragmatica, quella economico-giuridica (il secondo elemento del composto è certamente connesso con pretium), quindi l’interprete/traduttore sarebbe un “mediatore, sensale, arbitro del prezzo”. Trova le radici proprio in questo termine latino il concetto più moderno di traduzione come “negoziazione”, ovvero - secondo U. Eco - «un processo in base al quale, per ottenere qualcosa, si rinuncia a qualcosa d’altro» e che mette in gioco da una parte il «testo fonte» e la «cultura in cui nasce» e dall’altra il «testo d’arrivo» e la «cultura in cui appare»[15].
Tuttavia, con la fine della latinità e l’avvento delle lingue romanze, si attuò una differenziazione netta tra il traduttore e l’interprete. Già nel francese antico, dal secolo XIII, esistevano due termini per differenziare colui che operava nella lingua orale, il truchement [16], e colui che operava nella lingua scritta, il translateur. Il termine translateur fu però rimpiazzato nel XVI secolo con la parola (che è un italianismo) traducteur, risalente a Etienne Dolet[17] - come rileva Georges Mounin[18] - mentre il termine truchement assunse col tempo una valenza più complessa, talvolta negativa in senso deformante, talvolta più generica in senso di sostituto o metafora (gli occhi possono essere un truchement del cuore). Ad essi andò ad aggiungersi il termine ambiguo interprète, con la stessa valenza dell’italiano “interprete” e dell’inglese “interpreter”, colui che «è quel certo personaggio utile in banca, ufficio o agenzia di viaggi, ma è anche l’esegeta e l’esecutore ri-creativo»[19]. Il tedesco ha invece mantenuto la differenza, formalizzata da Friedrich Schleiermacher, tra una traduzione tecnica di contenuti comuni (per cui si usa il verbo dolmetschen) e una traduzione “ricreativa” di testi non quotidiani (per cui si usano i termini übersetzen/übertragen). In sintesi, è evidente già dall’analisi dei diversi termini utilizzati nelle lingue a tal proposito più rilevanti, come non solo non esista una definizione univoca e complessiva del “tradurre”, ma anche come i significati della traduzione non siano facilmente deducibili da un groviglio problematico a dirimersi.
Difatti, nonostante la ricerca di schematicità e di soluzioni attraverso approcci provenienti da svariate discipline, quali la linguistica, la psicologia, la psicolinguistica, la filosofa del linguaggio, l'ermeneutica e la semiotica, « non si può comunque proporre una definizione di traduzione che sia accettata su un piano generale e che tenga conto di tutti i fattori interessati al processo traduttivo. Tutto ciò sta nella complessità del problema stesso, complessità della quale finora nessun singolo approccio scientifico è riuscito ad avere ragione nella sua totalità»[20]. Tuttavia, al di là dei significati stricto sensu impliciti negli etimi dei termini per tradurre ed esplicitati da molti teorici della traduzione, risulta necessario comprenderne il significato in un senso più ampio.
A chiarire efficientemente lato sensu il “tradurre” è stato illuminante George Steiner - nella rivoluzionaria opera After Babel (1975) - per cui «ogni atto comunicativo è un atto di traduzione». Infatti secondo lo studioso «la traduzione è formalmente e praticamente implicita in ogni atto di comunicazione, nell'emissione e nella ricezione di ogni singolo atto di significazione, sia nel più ampio senso semiotico, sia negli scambi più specificamente verbali». Capire significa, dunque, decifrare e di conseguenza «la traduzione fra lingue diverse è un'applicazione particolare di una configurazione e di un modello fondamentali del discorso umano, persino quando questo discorso avviene in un'unica lingua»[21]. Ciò che Steiner precisa con assiduità nella sua opera è che la traduzione è innanzi tutto una prassi, un’attività spesso inconscia e quotidiana, tant’è che noi «traduciamo ad ogni istante quando parliamo e riceviamo segnali nella nostra lingua»[22]. Ciò non porta a negare che esista la traduzione in senso più usuale, che è quella che avviene con l’incontro/scontro tra due lingue diverse, anzi, è proprio la traduzione da lingua a lingua che riprova e rinforza la problematicità congenita in ogni scambio di significato.
A tal proposito potrebbe scaturire spontaneamente un interrogativo relativo all’enorme numero delle lingue e alla loro diversità, che è alla base del discorso sul senso del tradurre e la conditio sine qua non della traduzione. Invero, questo fatto contraddice i criteri base dell’economia, senza alcun principio chiaramente identificabile, essendo evidenti i vantaggi sociali e materiali offerti da una omogeneità linguistica. Motivi di natura geografica non paiono essere ragionevoli a spiegarne la natura, dato che, ad esempio, si riscontrano a distanze ravvicinate lingue fra loro incomprensibili, parlate in un’unica comunità. Esse rappresenterebbero uno “spreco” illogico per un’umanità che è invece sostanzialmente omogenea dal punto di vista biologico e psicosomatico. Lo stesso Steiner nella sua opera pioneristica si domandava: «Perché mai devono esistere due lingue? Anzi, perché mai sono state parlate, ad occhio e croce, più di ventimila lingue su questo piccolo pianeta?»[23]. Tale frantumazione linguistica ha portato a tentare di rintracciare il senso di tale disastro - secondo un’etimologia cara a Steiner, «pioggia di stelle dell’umanità» - in miti come quello della biblica Babele e in accomunabili spiegazioni mitologiche riscontrabili in culture altre.
Il problema e il senso della traduzione
Non a caso l’argomento della traduzione è stato spesso affrontato come il “problema” della traduzione, come recita anche il titolo di un’ambiziosa raccolta di saggi, Das Problem des Übersetzsens [24] ; un problema su cui non sempre è stato facile, e non lo è tutt’ora, fare luce in maniera definitiva. Una risposta inequivocabile e irremovibile ad esso non esiste; anzi, forse è un problema ancora vivo proprio perché presente intrinsecamente agli albori della sua nascita. Se ci troviamo a discutere di traduzione è a causa di “Babele”, «di quella primigenia confusione, così come ci è stata raccontata e tradotta. La superbia, la città, la torre. Il Dio che scende e punisce, confonde e disperde»[25]. Infatti, prima «tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole»[26], dunque l’esistenza della traduzione poteva assumere il senso di rimettere in comunicazione, far comprendere e avvicinare a vicenda culture e lingue diversificatesi, ma solo “after Babel”, termine quest’ultimo che secondo una curiosa e affascinante paretimologia deriverebbe da balal “confondere”, oppure da bab + El “porta di Dio”, come indicano molti etimologisti (assimilabile da taluni di essi anche al sumero Ka-dingir e all’assiro Bab-Ilu)[27]. Cogliendo lo stimolo di quest’ultima etimologia più scientificamente provata, la caduta di Babel e le annesse conseguenze non sarebbero da cogliere in mero senso negativo, come catastrofica dispersione e impossibilità di ritorno ad una primigenia comunicazione esente da difficoltà, ma come possibilità e dono delle diversità, che possano arginare, in linea teorica, un autocentrismo etnico e generalizzante, arricchendo la comunicazione stessa. Vista in questa prospettiva la traduzione «è un imperativo teologico, una ricerca ostinata di tutte le aperture, le trasparenze, le paratie attraverso le quali le correnti divise del linguaggio umano inseguono il loro fatidico ritorno a un unico mare»[28].
Dunque, ogni traduzione si baserebbe, almeno inconsciamente, su un principio di fiducia, confidando nell’esistenza di un nesso profondo tra le lingue e tra le persone (i cosiddetti “universali” tanto ricercati dai teorici[29] ). A ragion di ciò, se non tutto nello stesso identico modo - il che sarebbe impossibile poiché ad ogni epoca e civiltà corrisponde una “massa di linguaggio” dissimile - sarebbe possibile trasferire almeno il senso implicito, il senso profondo “dicendo quasi la stessa cosa”[30]. Tuttavia, nel corso della storia della traduzione, tesi “a favore” della traduzione, animate da spinte di attese umane - ovvero das Prinzip Hoffnung [31] - sono state accompagnate da tesi rette da un postulato di intraducibilità, che risale a un fondamento plurisecolare, secondo il quale ogni atto di traduzione porterebbe “verso il basso”, conducendoci lontani dal λόγος originario.
In particolare la poesia - e quindi la tragedia greca - non sarebbe traducibile, poiché presente una saldatura o, utilizzando le parole di Dante, un «legame musaico»[32] tra forma e contenuto, che non consente alcuna dissociazione. Proprio perciò la forza e l’ingegno di una lingua non sarebbero trasferibili, infatti «Kein Wort im Gedicht ist identisch» [33] , ovvero ciascuna parola possiede una propria unicità semantica in poesia, per cui la traduzione del genere poetico non risulterebbe altro che «profanation of the dead» [34] .
Eppure, a dispetto di ogni postulato di intraducibilità, scetticismo o condanna morale sulla traduzione, si continua a tradurre “nonostante Babele e grazie a Babele”. E forse il senso, ed anche il fascino e la bellezza della traduzione della poesia - e più in generale della parola umana - risiedono proprio in un senso di imperfezione, nel continuo creare e ricreare, titanicamente: sapendo di essere vinti nella limitatezza del possibile, ma di essere vincenti nella possibilità di sfidare l’impossibile . Come scrive il filosofo Paul Ricoeur «è proprio il lutto per la rinuncia alla traduzione assoluta a rendere possibile la felicità del tradurre», per cui, se quest’ultimo è «teoricamente incomprensibile», esso è anche, però, «effettivamente praticabile»[35].
Sebbene individuati dei limiti insormontabili, per cui la sconfitta del traduttore di fronte all’autore pare certa , il senso di tradurre ancora testi letterari antichi, e nello specifico il teatro greco, è rintracciabile proprio nella “scommessa” e nell’audace «sfida etica»[36], che ogni traduttore persegue quando decide di riprodurre in altra lingua e - dato che «le traduzioni invecchiano» come scrive Umberto Eco - in “nuova lingua” un testo letterario classico. Esso, essendo necessariamente legato allo hic et nunc di creazione, può essere in questo modo riscoperto, rivitalizzato e offerto ad un pubblico più vasto, rispetto a coloro che possedevano originariamente gli strumenti per coglierlo e a coloro che attraverso un grande studium sono riusciti a dotarsi di idonei strumenti e competenze di lettura[37].
Dunque, il senso del tradurre, a prescindere dal dono o dalla condanna della frammentazione linguistica, scaturisce fondamentalmente da un’esigenza pratica, di possibile comunicazione e fruizione, di comprensione di un testo che appare distante o comunque alium, e che attraverso una buona traduzione, fatta di imprescindibili perdite e adeguate compensazioni, riesce a essere “ospitato” in una nuova veste linguistica. In questo senso il traduttore non può che essere interprete, ovvero “negoziatore” - barattando termini, giostrandosi tra le possibilità di una linea source oriented o target oriented [38] - ma anche “ricreatore”, che si muova, come lo stesso Pasolini fece, in una condizione inclusa tra grande entusiasmo e grande inibizione rispetto a un testo classico.
Pertanto il traduttore, in qualche modo, non può che essere anche un traditore nel senso più completo e complesso del termine, ovvero colui che inganna e colui che rivela. Tradire deriva dal latino tradĕre “consegnare, dare in mano, affidare, trasmettere”, che solo secondariamente prende l’accezione di “consegnare ai nemici”. Proprio a partire da questa specifica accezione fu derivato il senso negativo del latino cristiano, in riferimento al tradimento (ovvero la consegna alle guardie) di Giuda nei confronti di Gesù. Attraverso questo passaggio, si è poi sviluppato il senso moderno e più usale del termine, ovvero “venire meno a un vincolo, a un patto d’amore”. Il traduttore, quindi, tradisce perché viene meno ad un adempimento spesso solo preteso, ovvero la traduzione perfetta, mito da abbandonare, ma tradisce anche perché “consegna un testo ad altri”, cambiandone l’abito e trasmettendone il senso profondo, altrimenti destinato a un circolo elitario, tradizionale. Ed anche in questo caso segnalare un nesso etimologico, quello tra tradimento e tradizione, può essere sorprendente, per notare che in fondo la tradizione non è altro che « la storia dei tradimenti passati » [39] .
Proprio attraverso una storia di tradizione, tradimento e traduzione un classico può continuare a vivere tramite continue e inesauribili riletture. O forse, come suggerisce Franco Buffoni - oltre che notevole poeta contemporaneo, un importante studioso di traduzione e fondatore della rivista «Testo a fronte» (1989) - piuttosto che di fedeltà al testo, un concetto ormai da superare, bisognerebbe parlare di «lealtà», infatti «il termine fedeltà connota guanciali, lenzuola e sotterfugi; il termine lealtà due occhi che fissando altri occhi dichiarano amore ammettendo un momentaneo “tradimento”»[40]. Questo concetto si addice, dunque, particolarmente bene al caso studiato in questo lavoro, per il quale aggrapparsi ad un rigido concetto di fedeltà impedirebbe di cogliere la portata della ricreativa traduzione pasoliniana, travisandola.
Approcci traduttivi per il teatro greco
Potrebbe sembrare contraddittorio affermare che tradurre i classici sia un lavoro da filologi, ma che allo stesso tempo non abbia nulla a che fare con l’attività filologica, ma è proprio ciò che intendeva Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff quando scriveva: « Die Übersetzung eines griechisches Gedichtes ist etwas, was nur ein Philologe machen kann, ist aber doch nichts philologisches »[41]. Da una certa ottica la filologia e la traduzione si possono porre in antitesi, essendo compito della prima ricostruire il testo il più vicino possibile all’originale precisandone il senso al momento della creazione, ed essendo la seconda, al contrario, rielaborazione e quindi necessariamente trasformazione, con riproduzione sempre del senso, ma di un senso legato imprescindibilmente anche all’epoca di traduzione. Infatti, ogni epoca ritraduce i classici e «la traduzione è forse il genere letterario che più limpidamente riflette la storia del gusto e della cultura»[42].
Se da una parte la filologia prevede un distacco freddo e oggettivo, la traduzione non può invece che risultare soggettiva, nonostante i possibili sforzi di ricercata oggettività e “trasparenza”, fino a potere essere guidata forse da un eccesso di ἐνθουσιασμός . Nonostante tale frattura, è un truismo precisare che un atto traduttivo presupponga un lavoro filologico, perché non si può tradurre ciò che non si capisce. Ma al di là di ciò, non bisogna pensare che il traduttore ideale sia necessariamente un filologo di professione, come «l’esperto musicologo può essere esecutore tecnicamente insufficiente o per la poca pratica con gli strumenti o perché incapace d’immedesimarsi in modo profondo con la partitura, fino a far nascere quelle vibrazioni e quegli echi che rendono possibile un dialogo fra il pubblico e il compositore»[43].
Difatti, anche per quanto riguarda le rappresentazioni del teatro greco del prestigioso INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico), a partire più che altro dagli anni ’60, le traduzioni furono affidate anche a letterati e poeti, né propriamente grecisti né filologi (come Pier Paolo Pasolini, Salvatore Quasimodo, Edoardo Sanguineti). Inoltre, in altri contesti, molti poeti italiani - quali Vincenzo Monti, Giacomo Leopardi, Ugo Foscolo, Camillo Sbarbaro e Cesare Pavese - si erano misurati in traduzioni di opere classiche greche e latine. In sintesi, un traduttore di classici, al di là di una formazione ed orientamento maggiormente storico-filologici o più spiccatamente poetico-artistici, non può che essere un mediatore tra due mondi, due culture, due lingue, ed un riproduttore del « sensum de sensu» [44].
Si tratta ora di stabilire quali siano le possibili modalità di approccio a questo delicato lavoro all’interno di una traduzione del teatro greco. È da premettere che fondamentali risultino essere la forma e la musicalità, considerato l’aspetto primario della messa in scena di questo particolare genere poetico, appartenente alla cosiddetta «civiltà teatrale»[45], ovvero quella di tutta la Grecia prellenistica, secondo la nota definizione di Gennaro D’Ippolito. Secondo quest’ultimo «tutti i testi greci da Omero all’età attica non rientrano stricto sensu nella nozione di letteratura ma sono testi teatrali, nel senso che tutti presuppongono un contesto pragmatico di fruizione, nel quale vi sia un pubblico di spettatori-ascoltatori, e naturalmente uno spazio scenico che accolga la performance»[46]. Celebre e assai citata è la frase del poeta Paul Valery, che scrive che «in poesia la fedeltà limitata al significato è una sorta di tradimento»[47] (con senso di tradire limitatamente negativo); a maggior ragione dunque lo sarebbe in un prodotto artistico destinato in origine a una fruizione teatrica, ovvero orale, pubblica, atta alla declamazione da parte di attori (o di aedi nel caso dell’epica).
Senza riepilogare la lunga storia della traduzione del teatro greco, si potrebbero classificare tutte le diverse traduzioni teatrali compiute nel susseguirsi dei secoli - come suggerisce Salvatore Nicosia – secondo i tre seguenti aspetti formali: «poesia, prosa, o verso a verso» [48]. Lungi dal definire una forma come migliore rispetto alle altre in senso assoluto, ci si può limitare a fare delle considerazioni in merito agli aspetti favorevoli o sfavorevoli di ciascuna di esse, valutandone i contesti. La prima forma, in linea di principio, potrebbe tendere a un tentativo di riproduzione del metro greco oppure all’utilizzo di un metro “equivalente” già canonizzato dalla tradizione poetica della lingua con cui si traduce.
Nel caso della lingua italiana può essere esemplificativo ricordare i tentativi di tre importanti poeti quali Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, accomunabili per la ricerca di una trasposizione del metro e del ritmo dei componimenti greci[49]. Se il primo sperimentò con le Odi Barbare la possibilità di attualizzazione nei metri tradizionali italiani ricreando l’aspetto esteriore del verso greco, il secondo mirò invece a una trasposizione metrica in inediti versi italiani, mentre il terzo concentrò la sua ricerca in una riproduzione ritmica e strofica della poesia greca.
Nel primo dopoguerra con gli orizzonti di attesa e i gusti mutati, i traduttori rinunciarono a tale predilezione, secondo una considerazione che lucidamente riuscì ad esprimere Ezra Pound: «La melopea [l’aspetto metrico-ritmico di qualsiasi componimento poetico] può essere apprezzata da un orecchio straniero dall’orecchio sensibile, anche se egli ignori la lingua in cui la poesia è scritta. È praticamente impossibile trasferirla o tradurla da una lingua a un’altra, tranne forse per puro miracolo, e mezzo verso alla volta»[50]. Dunque, secondo questo concetto, il modo ottimale per riprodurre una melopea assimilabile all’originale sarebbe quello di procedere per unità ritmiche brevi.
Al di là di quanto scritto, e limitandoci ad alcune importanti traduzioni del ventesimo secolo, può essere interessante ripercorrere dei casi di scelta formale traduttiva a riguardo dell’opera presa in questione. Proprio in vista della prima rappresentazione del “futuro” Istituto Nazionale del Dramma Antico, per la traduzione dell’ Agamennone (1914) Ettore Romagnoli (traduttore e anche regista della tragedia) scelse la forma poetica; ed essa fu scelta da Romagnoli anche per la traduzione delle Eumenidi (1921). Tale forma poetica non poté che vertere sull’utilizzo dell’endecasillabo sciolto, verso tradizionale della poesia italiana, reputato il più consono ad esprimere il trimetro giambico delle parti dialogate della tragedia. Esso risente, evidentemente, degli stilemi provenienti dalla langue poetica italiana, canonizzata a partire dalla dizione lirica del Canzoniere di Francesco Petrarca. La traduzione risulta, quindi, particolarmente soggetta a fenomeni di riuso o in ogni caso a «riecheggiamenti involontari»[51]. Se il tentativo è quello di mantenere un certo grado di elevatezza di stile, tipico (parzialmente) della tragedia e di parte della trilogia eschilea, è anche vero che questa scelta di mediazione attuata per un determinato pubblico italiano e secondo una lunga tradizione letteraria risente nell’attualità di un cambiamento di gusto e orizzonti. Oltre a ciò, l’utilizzo di tale verso porta spesso a costringere la resa traduttiva entro uno schema rigido, cosicché ne conseguono distanziamenti inevitabili rispetto al testo originale, giustificabili solo in base allo schema metrico, quali artificiose postposizioni, addizioni di termini “riempitivi”, sottrazioni, fastidiosi troncamenti. Inoltre, lo stile aulico di Romagnoli, considerabile l’ultimo grande traduttore del filone classicistico, non rende pienamente giustizia del tono sì poetico, ma non di certo pomposamente retorico, della trilogia eschilea. Difatti, il registro linguistico è considerabile aulico in greco, ma limitatamente alle parti cantate.
La scelta della prosa si giova, al contrario, dell’evidente vantaggio di maggiore libertà nella scelta traduttiva - essendo svincolata da uno schema - e ciò può comportare, in linea teorica, una resa più efficace e vicina al testo fonte. Nonostante la possibilità di mantenere una ritmicità e musicalità nella prosa, e con l’ulteriore beneficio di un’assenza di stilemi coercitivi, questa via traduttiva comporta un forte mutamento della forma originaria, e può tendere a portare “verso il basso” (potendo rendere meno ardua anche la recitazione) per una resa più moderna del genere tragico. Per quanto riguarda la traduzione dell’ Orestea in prosa, si possono ricordare il notevole lavoro di Manara Valgimigli - che inaugura, appunto, nel secondo dopoguerra il X ciclo di rappresentazioni siracusane con l’ Orestea (1948) - la traduzione di Mario Untersteiner (1946-47) e quella più recente, di fine Novecento, di Maria Pia Pattoni (1995).
La forma di traduzione lineare fu invece quella seguita da Pier Paolo Pasolini per la traduzione dell’ Orestiade (1960) commissionatagli da Vittorio Gassman per la messa in scena al Teatro di Siracusa. Pur non “elevandosi” attraverso la dignità poetica dell’endecasillabo, non si può parlare nemmeno di resa prosastica, essendoci l’andamento e la resa grafica del verso, che risulta aderente (seppure non affatto rigorosamente) a quello eschileo. In questo caso specifico di traduzione, che verrà analizzato in seguito più dettagliatamente, «la tendenza linguistica generale è stata a modificare continuamente i toni sublimi in toni civili» con «un avvicinamento alla prosa, all’allocuzione bassa, ragionante»[52], non soltanto per un processo di attualizzazione del testo, ma piuttosto per una ricerca di coerenza con l’interpretazione ideologica e stilistica del testo greco, che Pasolini perseguì.
Ma al di là della forma, che in fondo potrebbe rivelarsi anche un «falso dilemma», poiché «rientra a pieno titolo nella categoria di testi poetici una prosa il cui valore sia legato alla forma (del contenuto e dell’espressione), e pertanto anche agli elementi ritmici»[53], le maggiori difficoltà di tradurre il teatro greco sono date da due tipi di fattori. In primis dal fatto che si tratta di un testo antico, per cui è necessaria una ricostruzione del contesto non solo letterario, ma anche socio-politico, ed in secundis per l’aspetto peculiare del genere preso in questione. Difatti, risulterebbe fondamentale, oltre a una “fedeltà semantica” e alla buona resa formale, il concetto di “fedeltà scenica”, come sottolinea D’Ippolito, per cui «la libertà di un traduttore di teatro deve […] agire entro il rispetto delle unità semiologiche», ovvero essere rispettosa «dell’ordine e della qualità degli orientamenti deittici»[54], essendo appunto l’asse deittico l’elemento specifico del sistema segnico teatrale.
Delineate le generalità dell’argomento e percorse le necessarie premesse, si può procedere ora ad analizzare più specificatamente la linea pasoliniana adottata nella traduzione, attraverso le ardite scelte della sua scommessa traduttiva, attraverso dei proficui confronti con altre traduzioni, quali quella francese di Paul Mazon (1920) e quelle italiane di Ettore Romagnoli (1921), Mario Untersteiner (1946-47), Manara Valgimigli (1948) e Maria Pia Pattoni (1995). Certamente, risulta proficuo tenere in considerazione le recensioni e contro-recensioni che ne conseguirono; per poi infine estrapolare il fulcro del rapporto tra Ὀϱέστεια di Eshilo e Orestiade di Pasolini.
2. Pasolini traduttore di Eschilo
Ci sono delle cose che il sistema non può assimilare, non può digerire. Una di queste, per esempio, è proprio la poesia, perché secondo me è inconsumabile. Uno può leggere migliaia di volte un libro di poesia e non consumarlo. La consumazione è del libro, è dell’edizione, ma non della poesia [55]
PIER PAOLO PASOLINI
L ’ Orestiade : l’importanza del contesto
Essendo liberi dalla presunzione di riuscire a trovare una traduzione ideale e perfetta, svincolata dall’epoca, dal gusto e dagli orizzonti soggettivi del traduttore[56], si può cercare di seguire quale sia stato l’approccio del poeta italiano nei confronti della tragedia eschilea. Tuttavia, come ulteriore, ma necessario preambolo ad un’analisi dei testi, è importante considerare il contesto e le condizioni che ruotarono intono alla traduzione eseguita da Pasolini. Difatti, solo in questo modo «si può leggere nella giusta angolatura questa Orestea: non allontanandola dall’ambito in cui ebbe vita e tenendo ben presenti sia l’occasione teatrale che ne richiede la nascita sia i motivi artistici, personali, umani e poetici propri dell’autore»[57].
Non fu propriamente egli sua sponte a decidere di prendere tra le mani il testo eschileo, per renderlo in un nuovo habitus, ma l’opportunità nacque per un evento che potremmo dire fortuito, ovvero la richiesta da parte dell’attore Vittorio Gassman di tradurre l’intera trilogia per la messa in scena al teatro di Siracusa, che avvenne il 19 maggio del 1960 sotto la regia di Gassman stesso e Luciano Lucignani, rientrando all’interno del progetto di Teatro Popolare di Gassman. La scelta di Pasolini come traduttore atipico, ma in linea con gli scopi della «decisa, intransigente, interpretazione 'storica'»[58] ricercata dai registi, che rifiutavano una resa “archeologica” o “estetica” e condividevano le teorie marxiste contenute nell’ Aeschylus and Athens di George Thomson, fu così strenuamente sostenuta da Gassman al punto che l’INDA - non volendo rinunciare al rinomato attore - non poté che accettare[59]. La titubanza dell’Istituto nei confronti di Pasolini, se, da una parte, era dovuta alla traduzione insolita che il poeta avrebbe probabilmente realizzato per un pubblico abituato, diversamente, a rese “archeologiche”, dall’altra, verteva sul fatto che egli si trovasse nel bel mezzo di un ciclone di scandali, provenienti sia dalla sua vita personale che dalla polemica sui suoi romanzi Ragazzi di Vita (1955) e Una vita violenta (1959).
[...]
[1] F. SCHILLER, Der Graf von Habsburg, in Gedichte, 1803, vv. 47-50.
“Come la fonte da nascoste profondità / Così il canto dei poeti dall’intimo risuona / E risveglia la violenza degli oscuri sentimenti / Che nel cuore meravigliosi dormivano” n. d. t.
[2] Questo lavoro è nato primariamente come tesi triennale di Letteratura Greca (Università di Cagliari, 2015) con relatrice la prof.ssa Patrizia Mureddu.
[3] Espressione che Pasolini preferiva al più usato “Orestea”.
[4] Da precisare che il nome della trilogia Ὀρέστεια (Agamennone, Coefore, Eumenidi) e il nome stesso di Εὐμενίδες non risalgono quasi sicuramente ad Eschilo, ma ad una tradizione seriore.
[5] Istituto Nazionale del Dramma Antico.
[6] Secondo il pensiero di G. Steiner una teoria della traduzione è soltanto o «una maniera di designare un modello» oppure è «una sottosezione di tale modello» e può corrispondere o «a una ‘teoria’ del linguaggio» oppure «avere da essa una rigorosa dipendenza formale», cfr. STEINER 1975 (19922), p. 335.
Per F. Fortini, invece, una teoria della traduzione «non sarebbe altro che una teoria della letteratura e presenterebbe un eguale complessità e le medesime contraddizioni», cfr. FORTINI 2011, p. 71.
[7] Termine coniato da G. Mounin in Les problèmes theoriqués de la traduction. L’italiano “traduttologia” è un calco semantico utilizzato da F. Buffoni a partire dal convegno di Bergamo su La traduzione del testo poetico (1988). Tuttavia, in Italia resta ancora un termine del «gergo specialistico», spia di un rifiuto a «concepire l’esistenza di una scienza della traduzione», cfr. BUFFONI 2016.
[8] JERVOLINO.
[9] Leonardo Bruni (1370-1444) può essere considerato il primo trattatista moderno della traduzione grazie al suo “De interpretatione recta” (ca. 1420).
[10] L’espressione è vocabulum graecum vetus traductum in linguam romanam. Cfr. Eco 2003, Folena 1991.
[11] Dal part. pass. latino di trānsferō, trānslātus, passando attraverso i termini dell’antico francese translateur, translation, translater.
[12] FOLENA 1991, pp. 5-6. Cit. in JERVOLINO.
[13] EBELING 1959, p. 243: «Die Vokabel hat drei Bedeutungsrichtungen: aussagen (ausdrücken), auslegen (erklären) und übersetzen (dolmetschen). Welcher Bedeutung die Priorität zukommt, ist sprachgeschichtlich nicht festzustellen», cit. in JERVOLINO.
[14] FOLENA 1991, pp. 5-6.
[15] ECO 2003, p. 18.
[16] Dall’arabo tariumān (torismany in catalano), indica originariamente coloro che traducevano dal saraceno allo spagnolo.
[17] Étienne Dolet (1509-1546), umanista, poeta, filologo, traduttore francese. Autore della Manière de bien traduire d’une langue en aultre (1540).
[18] Cfr. MOUNIN 1965, p. 18.
[19] STEINER 1975 (19922), p. 305.
[20] APEL 1993, p. 19.
[21] STEINER 1975 (19922), p. 12.
[22] Ivi, p. 13.
[23] Ibidem.
[24] STÖRIG 1969.
[25] NERI, TOSI 2009, pp. 2-4.
[26] GENESI 11, 1-9: trad. CEI.
[27] ZORELL 1940-84. Cit. in NERI, TOSI 2009, p. 4.
[28] STEINER 1975 (19922), p. 296.
[29] Si pensi al LAD (dispositivo di acquisizione linguistica) della teoria innatista-cognitivista di Noam Chomsky, così universale al punto da decodificare qualsiasi lingua umana.
[30] Espressione ripresa dal libro di Umberto Eco, cfr. Eco 2003.
[31] Termine che da titolo a un’opera del filosofo Ernst Bloch (in tre volumi del 1954, 1955, 1959) sugli impulsi utopici presenti soprattutto in arte, letteratura e religione.
[32] Dante Alighieri ribadisce nel Convivio (I, VII 14): “Nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la sua loquela in altra transmutare, senza rompere tutta sua dolcezza e armonia”.
[33] Cit. in STEINER 1975 (19922), p. 293; da una lettera «alla contessa Izzo nel marzo 1922» del poeta Rainer Maria Rilke.
[34] Cit. in STEINER 1975 (19922), p. 291 sgg.; dalla poesia On Translating ‘Eugene Onegin’ di Vladimir Vladimirovič Nabokov. Lo stesso poeta «afferma, riferendosi alle versioni inglesi di Puškin, che nella traduzione di versi tutto ciò che non sia “la letteralità più sgraziata” è inganno».
[35] RICOEUR 2001, pp. 44 e 69, cit. in D’ACUNTO 2013.
[36] Cfr. RICOEUR 2001.
[37] E anche in questo caso è ampio e controverso il dibattito sulla possibilità di un “moderno”, seppure esperto, di fruire di un testo classico allo stesso livello di un “fruitore ideale” vissuto nel tempo e contesto in cui il testo fu scritto.
[38] Cfr. ECO 2003.
[39] TORSELLI 2004.
[40] BUFFONI 2012, p. 17.
[41] “La traduzione di una poesia greca è qualcosa che solo un filologo può fa, ma che non ha eppure niente di filologico” (ndt), WILAMOWITZ 1891, p. 1.
[42] MORANI 2003, p. 1.
[43] Ivi, p. 2.
[44] Terminologia utilizzata da San Gerolamo in contrapposizione alla traduzione verbum e verbo.
[45] G. D’IPPOLITO, 1983, pp. 155-172 .
[46] G. D’IPPOLITO 1988, pp. 76-77.
[47] VALERY 1956, p. 23.
[48] NICOSIA 2009, p. 84.
[49] Cfr. PRETAGOSTINI 1988, p. 57 e sgg.
[50] POUND 1957, pag. 47. Cit. in PRETAGOSTINI 1988, p. 61.
[51] NICOSIA 2009, p. 84.
[52] PASOLINI 1960 (19882).
[53] D’IPPOLITO 1988, p. 76.
[54] Ibidem.
[55] PASOLINI 2005, p. 65. Cfr. anche La poesia inconsumabile, http://www.youtube.com/watch?v=1My7T3WwxnA: «Io produco una merce , la Poesia, che è in realtà inconsumabile. Morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata».
[56] «È proprio dall’abbandono di ogni posizione normativa che si gioca la possibilità di dare una impostazione nuova ai problemi della traduzione e al loro studio. Non ha nessun interesse continuare a discutere se si possa o non si possa tradurre, partendo dall’idea di traduzione come copia perfetta che per principio non si dà», MATTIOLI 1983.
[57] FAGIOLI 1980, p. 12.
[58] Dalla lettera di Lucignani a Thomson (5 ottobre 1959), in PASOLINI 2001, a cura di SITI e DE LAUDE, p. 1215.
[59] Nonostante «dalle lettere ancora conservate nell’Archivio INDA si ricava che inizialmente l’Istituto aveva proposto di affidare la traduzione di Agamennone a Traverso, di Coefore a Quasimodo e di Eumenidi a Perrotta», cfr. BANFI 2008.
- Quote paper
- Dr. Francesco Ottonello (Author), 2018, Pasolini traduttore di Eschilo. "L'Orestiade". Possibilità e limiti traduttivi nella tragedia greca, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446666
Publish now - it's free







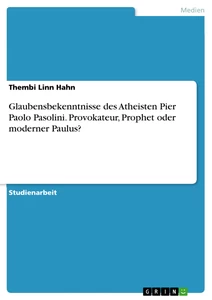












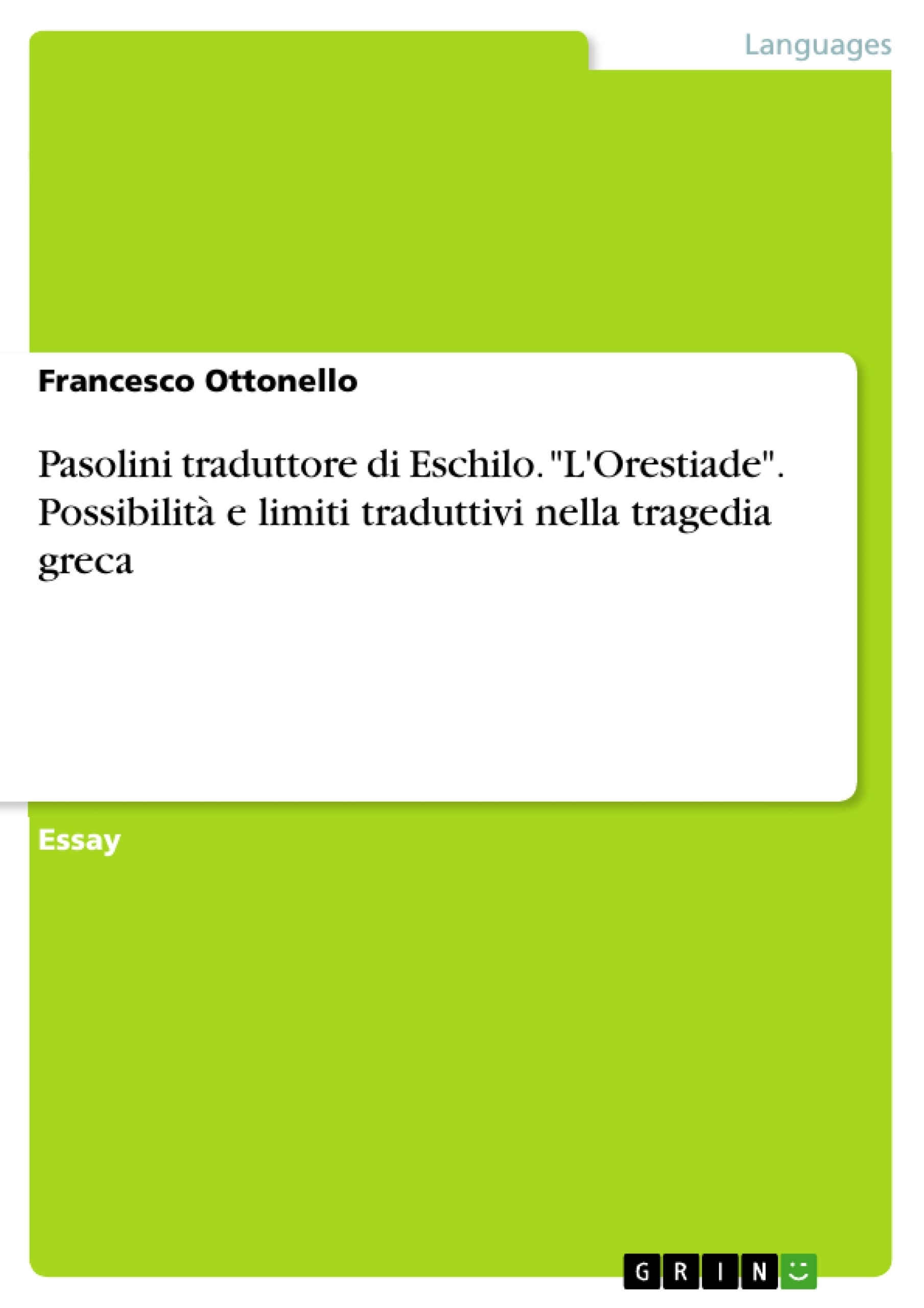

Comments