Excerpt
Indice
1. Introduzione
2. Differenza fra lingue
3. Approccio fenomenologico
4. Lingue a due generi e a tre generi
5. Maschile e femminile in tedesco. A: nomi; B: pronomi; C: caso genitiv
6. Genere maschile e femminile nella lingua e riflesso sull’identità psicologica dell’individuo
7. Conclusioni
Bigliografia essenziale
1. Introduzione
Questo studio prende le mosse da una considerazione semplice nel suo fondamento: che la lingua sia punto di vista sul mondo. Quest’affermazione contiene alcune conseguenze che possono articolarsi come segue.
Che la lingua sia punto di vista sul mondo comporta innanzitutto che essa sia luogo di determinazione della realtà e non qualcosa di infinito che tutto comprende e abbraccia, e ciò nonostante sia estremamente arduo identificare i confini di una lingua[1]. La lingua è anzi il “luogo” di determinazione per eccellenza. La differenza fra le lingue mostra a mio avviso proprio questa qualità della lingua, è cioè la possibilità di nominare la realtà, ovvero di esprimere qualcosa a partire da una ineliminabile determinatezza. Questa determinatezza è la finitezza stessa della lingua.
La finitezza della lingua può esser colta sia considerando l’aspetto sonoro delle parole, sia quello grafico-rappresentativo, sia quello concettuale.
Qualunque parola volessimo mai pronunciare, la pronunciamo sempre partire dalla determinatezza della sua forma sonora. Il tono stesso con cui una parola viene pronunciata non solo ha caratteristiche fisiche precise, ma anche può imprimere alla parola stessa una direzione espressiva piuttosto che un’altra. Si pensi per esempio alle svariate sfumature di voce, accento, intonazione – che qui, per via dello strumento scritto di cui mi servo, non possono essere esemplificate –, con le quali può essere detta la parola “perché”. Limitandoci a questo esempio e muovendoci nella grossolana distinzione che, grazie all’intonazione può tracciarsi sto esempio e muovendocisotto il profilo della semantica, si può osservare come nella lingua italiana la parola perché assuma un significato causale ovvero un significato interrogativo soltanto a partire dalla modalità sonora con la quale la parola è pronunciata. Dunque persino il tono di una parola può condurre quest’ultima verso una determinatezza, di significato o di significante.
Ma anche senza considerare l’aspetto fisico-sonoro e fugace della vox, pur nel tacito prodursi della scrittura, qualunque parola volessimo scrivere, l’imbrigliamo sempre dentro alla finitezza della forma che tracciamo sul supporto che abbiamo scelto per sostenerla. Questa determinatezza della parola scritta è condizionata sia dalla forma grafica della parola[2], sia, in condizione di identità della forma grafica, dal supporto (pietra, tavoletta di cera, pagina di carta, pagina elettronica) che si potrebbe mai scegliere a sostegno del messaggio scritto che si vuole trasmettere. Per quanto riguarda il primo aspetto, si pensi alla resa grafica delle parole, che specialmente nel nostro tempo indubbiamente si avvale dell’esperienza di rottura della forma scritta così come è stata maturata all’inizio del XX secolo durante il periodo di profonda trasformazione che ha interessato tutte le arti della cultura occidentale[3] e che al giorno d’oggi è tanto rilevante nel linguaggio della pubblicità (tanto che in questo ambito si è affermata una competenza specifica, la figura professionale del “grafico pubblicitario”). Per quanto riguarda invece il supporto su cui la parola è scritta, si tratta sempre di qualcosa che possiede una vicenda di possibile distruzione e vanificazione attraverso l’opera livellante del tempo, opera livellante cui l’uomo stesso presta un aiuto essenziale nella predisposizione dei mezzi per la scrittura virtuale. I mezzi di supporto della lingua scritta sono caratterizzati da una determinatezza e da una finitezza che ne condiziona le possibilità di diffusione attraverso lo spazio e di permanenza nel tempo. Si pensi alla scrittura al computer, dove, diversamente dal caso della pietra e della pagina cartacea, si può cancellare apparentemente senza lasciare il segno di quanto si è scritto, in un illusorio processo di risalimento a ritroso nell’ordine del tempo come se la parola non fosse mai stata scritta, ovvero molto velocemente in avanti come se il tempo avesse già compiuto la sua opera di livellamento, benché in realtà resti comunque una traccia di quanto scritto, non soltanto nella memoria di chi ha scritto, letto o cancellato, ma anche nella memoria del calcolatore. Ovvero si pensi alla comunicazione per posta elettronica, che, una volta premuta la funzione di invio, viene lanciata fra miliardi di miliardi di parole e di caratteri in quello spazio immateriale che è la rete per giungere in pochi secondi nell’ordine corretto al destinatario del messaggio. Anche in questo caso la lingua si caratterizza per la sua determinatezza, che oltre a concretarsi nel contenuto finito del messaggio (che comunica questo e non quest’altro), patisce una sorta di finitezza in quanto il messaggio è soggetto alla possibilità di essere eliminato semplicemente se il destinatario preme il tasto “cancella”. E anche qui, tuttavia, si lasciano tracce di varia natura che non consentono il riassorbimento della parola in una dimensione di indeterminatezza, in alcunché di indifferenziato.
Ma, soprattutto, la essenziale finitezza della lingua può cogliersi riflettendo sul suo aspetto concettuale, o sulla sua “capacità” di concettualizzazione. Qualunque porzione di realtà vogliamo che la parola colga, essa non può essere stretta nelle maglie della lingua se non a partire dalla finitezza, cioè sfrondando di volta in volta aspetti della realtà che invece possono essere considerati rilevanti da una lingua diversa.
Per rimanere nell’ambito di un confronto fra italiano e tedesco, sotteso in questo scritto, vedasi per es. la differenza fra la parola italiana “gioiello” e uno dei termini corrispondenti tedeschi, “Kleinod”. “Kleinod” è “gioiello”, “monile”, “gioia”, “tesoro” nel senso di oggetto piccolo, grazioso, finemente lavorato, da custodire e proteggere[4], che in sé assomma il senso di uno scambio sociale che avviene come piccolo segno di attenzione o di ospitalità[5] e pertanto presenta una sua unicità, un valore di pegno che tutto eclissa e che ne motiva la radice etimologica che su questa unicità (la medesima radice di Öde, solitudine)[6] batte l’accento. Per questo il termine si è evoluto nel tempo anche a significare oggetto prezioso, ma nel senso di qualcosa che possiede un valore tale da essere “insostituibile” (unersetzlich)[7], dunque piuttosto “unico” che “inestimabile” (unschätzbar).
Nel caso della lingua italiana, invece, “gioiello” mutua la propria origine dal francese antico joel, “gioco”[8] e, in lingua italiana, contiene un’immediata assonanza con “gioia”, nell’ambito dei cui significati possibili si pone anche in rapporto di sinonimia. Proprio per questo richiamo a “gioia”, che nel senso più comune indica uno stato d’animo quanto mai intenso ancorché passeggero, il termine gioiello ritaglia della realtà che descrive qualcosa di effimero, di superfluo, giacché il significante di una sensazione impegnativa ed elevata, epurata e vagamente connotata in senso sacrale, come la gioia, si àncora al significato del cospicuo valore monetario del gioiello quale oggetto prezioso. Una nota di superfluità aleggia sul termine italiano gioiello, sorta di felicità riservata alle persone abbienti. Ciò non impedisce l’uso figurato della parola in questione, in un’espressione quale per es. “i miei figli sono i miei gioielli”, che non fa che rimarcare l’iniziale concezione del termine, venata dall’idea di una sottostante ripartizione in classi sociali fondata sulla ricchezza materiale.
Il rapporto di corrispondenza ma anche di sostanziale imperfetta traducibilità che vige fra Kleinod e gioiello vorrebbe offrire un esempio di come la parola, considerata sotto il profilo concettuale, possa cogliere soltanto alcuni tratti, alcuni elementi determinati della realtà e debba necessariamente tralasciarne altri. Un concetto che racchiuda in sé l’infinito, nel senso della infinita complessità che può cogliersi dal sensibile, non può darsi, benché – invece, sorprendentemente – infinita sia la concatenazione di rimandi aperta dalla determinatezza e che appare visibile anche soltanto riflettendo, per es., sul concetto di campo semantico.
Che la lingua sia punto di vista sul mondo porta con sé anche il fatto che, nel concetto, pensato proprio come ciò che prende-insieme[9], sfrondando la realtà che in tal modo fa accesso dentro all’atto del nominare, la parola trattenga per illuminarli soltanto tratti parziali della realtà, per lasciarne altri in ombra. Questo lasciar-in-ombra è proprio della finitezza della parola, sia nel senso che essa non riesce mai ad esaurire, nel rifletterla, l’infinita complessità del reale, sia nel senso che tale infinita complessità, a partire dalla quale la parola riesce a ritagliare e illuminare soltanto alcuni tratti, resta custodita nel buio. Questo ritirarsi nell’ombra di ciò che non accede alla cattura della parola, ben lungi dall’essere di “secondaria importanza”, si rivela invece ciò a partire dal quale è possibile ogni possibile rinnovamento della lingua, ciò che costantemente consente l’immissione di nuova linfa nel linguaggio e che di questo realizza l’evoluzione continua, sia mediante la creazione di nuovi vocaboli, talora recepiti da lingue straniere e particolarmente favorita dallo sviluppo della tecnica (si pensi a parole come “smog”, “pendolino”, “implementazione”, “gol”, “blog”, “mappatura”, “partenariato”, “lapalissiano”, “fotocopia”); sia mediante l’estensione di vocaboli già esistenti a enti ulteriori (si pensi per es. all’estensione semantica subita da “sito”, “palinsesto”, “velina”, “trasmissione”, dall’aggettivo “fatto”), che può arrivare a produrre l’affievolimento e in qualche caso addirittura la scomparsa del significato originario (cfr. per es. “enoteca” che da un originario significato di “collezione di bottiglie di vini pregiati”[10], è passato a indicare comunemente il locale in cui si possono sia acquistare, e anzi, per lo più, consumare non solo vini ma anche stuzzichini; oppure “pillola” che per antonomasia è l’anticoncezionale e non un qualunque farmaco in pastiglie).
Questo rapporto fra luminosità-chiarità dell’ente – almeno di alcuni suoi tratti –, che accede nella parola, e ombra in cui i tratti non nominati si ritirano[11], ombra che custodisce le possibilità stesse di trasformazione della lingua, trova secondo me una sintetica quanto efficace espressione nella bella poesia di Paul Celan:
klopf die
Lichtkeile weg:
das schwimmende Wort
hat der Dämmer[12]
La poesia appena riportata ci ricorda come la parola trovi nell’ombra sostegno vitale. La possibilità della parola di sostentarsi non risiede nei puntelli fatti apposta per sorreggerla, nei “cunei di luce” (Lichtkeile) che costituiscono la sua essenza visibile, la luminosità che essa, pronunciata, scritta, detta, pensata, immaginata, porta con sé; e ciò perché in maniera del tutto sorprendente perché non necessaria, direi quasi “misteriosa”, la parola, nei suoi tratti rischiarati è soggetta a un curioso logorio, una sorta di sfilacciamento costante, che forse è l’esito inevitabile per aver abusato dell’uno o l’altro dei suoi tratti visibili, per aver impiegato le parole in modo “disattento”, “parlando senza pensare” a fondo. La possibilità della parola di trarre linfa vitale e sostegno, rinnovamento e permanenza all’interno di una lingua risiede invece nella parte che essa lascia in ombra e che la contiene, con l’ambivalente fermezza dell’oscurità incipiente, che argina la luce del giorno (Dämmer: cfr. Dämmerung, “alba/crepuscolo”, Damm, “argine”) e possiede la forza che ammansisce e che dunque riconduce a misura (cfr. Dämmer nell’antico significato di “domare” ancora attestato nel Dizionario della lingua tedesca dei Fratelli Grimm[13], ma espunto dall’edizione più recente del Dizionario Duden).
In base a questo necessario rapportarsi fra forza rischiaratrice, diradante (proprio in quanto essa “sfronda”), della parola, e ombra che la sostiene, la lingua concepita quale punto di vista sul mondo appare contrassegnata da un’inevitabile “parzialità”. Come il punto di vista è di per sé relativo e non consente di cogliere tutto ciò che potrebbe offrirsi alla percezione, così la lingua, nella istituzione di connessioni e rimandi fra i suoi elementi costituitivi intesse una trama luminosa che tuttavia porta sempre con sé, non vista e non visibile, un’ombra buia, che le sta costantemente attaccata come le sue possibilità di sviluppo[14].
2. Differenza fra lingue
La differenza fra le varie lingue è concretamente rilevabile soltanto in virtù di quest’ombra che accompagna la lingua e che costituisce il pozzo senza fondo da cui ogni lingua attinge la propria forma, da cui forgia le regole della sua grammatica che stabiliscono la correttezza degli enunciati, l’ammissibilità di determinate concatenazioni di parole, delle espressioni cui può farsi ricorso nell’atto del dire. La differenza fra le lingue non può che risiedere nella possibilità di tagliare, di volta in volta, a partire da un punto di vista determinato, situandosi in un “luogo” via via differente del modo di aprirsi al mondo[15], alcuni aspetti di ciò che si vuole nominare i quali vengono in qualche modo considerati essenziali da quel punto di vista, tanto essenziali da poter essere perpetuati in qualcosa come la parola, che presenta di per sé un tratto schematico.
Proprio perché la parola, nella sua finitezza, non può non ritagliare soltanto determinati elementi dell’ente che nomina, essa assume una caratteristica schematicità, che è anche il suo tratto mortifero, perché è proprio in virtù di questa sua schematicità che essa può applicarsi a enti del mondo caratterizzati da qualche tratto di somiglianza: si pensi per es. alla parola “rosa”. Essa può indicare di volta in volta un fiore diverso (o anche, metonimicamente, la pianta che genera questo fiore) identificato per la sua fragranza, per il velluto e la freschezza dei suoi petali assiepati, fitti attorno agli stami e ai pistilli, a prescindere dal suo colore (abbiamo varietà di rose rosse, bianche, gialle, rosa ecc.); e può voler dire anche la “rosa dei venti”, ovvero la “rosa” o “rosetta” che indica uno dei tagli con cui può faccettarsi il diamante; ma si può anche invece ascoltare al tempo presente tutt’altro tipo di rosa prestando attenzione alla “rosa blu sulla pelle tua” della canzonetta[16], che della rosa vegetale è una raffigurazione grafica, ovvero riandare con la memoria indietro al tempo della “guerra delle due Rose”, dove “rosa” è simbolo di secondo grado che parte dalla raffigurazione della rosa-fiore che a sua volta simboleggia un casato. La parola “rosa” si attaglia anche alla rosa che non ha profumo, a quella dipinta su di un pannello, su di una tazzina, su di un quadro impressionista che del fiore in parola non lascia distinguere i petali e che guadagna il proprio nome soltanto a debita distanza: come si vede per es. nel quadro di Edouard Manet che raffigura le rose in un vaso:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[17]
La stessa parola “rosa” vale anche per la rosa-fantasma se mai avessimo necessità di nominare gli enti di un mondo soprannaturale in cui si muovono entità del genere, così come per la rosa di stoffa cucita su di un vestito o per la “rosa finta” che alcuni pongono sulle tombe per ornarle, da un certo punto di vista, in maniera meno caduca di quanto non riescano a fare i fiori freschi. La parola “rosa” può essere estesa a diversi enti del mondo soltanto grazie alla sua natura di schema che le consente di trasporsi ora qui, nel mondo vegetale, ora lì, nel mondo simbolico dell’arte, della narrazione storica e così via, mantenendosi nella capacità di nominare l’essenza di quell’ente (si pensi di nuovo alla rosa blu della canzonetta che riusciamo a “vedere” con gli occhi dell’immaginazione semplicemente ascoltando il canto e la musica).
Proprio perché la lingua prende le mosse dalla finitezza, proprio perchè essa ritaglia dall’indeterminato in cui sono immersi gli enti, è ben comprensibile che una lingua ritagli alcuni caratteri di un ente, mentre un’altra ne ritagli altri. È proprio il carattere finito della lingua che inevitabilmente genera le differenze fra una lingua storica e l’altra, e il fatto che ciascuna lingua è punto di vista sul mondo, e al contempo un insieme di parole che possono essere combinate in base a un insieme di regole che sono esse stesse un “tagliare”, un ammettere certe espressioni come “corrette” e ricusarne altre come “insensate” o “sbagliate”, non può non avere ripercussioni profonde sul modo della lingua di rapportarsi al mondo, in maniera così profonda da costituirlo, e ciò perché non possiamo incontrare enti al di fuori della griglia del linguaggio[18] il quale ci calca come una cicatrice e ci marca come “i parlanti”.
3. Approccio fenomenologico
La differenza fra le lingue, in particolare per quanto riguarda il tentativo di motivare o almeno descrivere l’atto con cui si dà un nome alla realtà intorno a sé trova la propria spiegazione in vari fattori, ma uno sicuramente deve avere, o almeno aver avuto, sino a un passato non troppo lontano[19], un peso preponderante rispetto agli altri.
Mi riferisco in particolare all’orientamento fenomenologico che deve aver condizionato la forma delle parole e che fa tutt’uno con la necessità di dare un nome agli enti intorno a sé i quali a seconda delle situazioni geografiche e climatiche presentano caratteristiche differenti, ovvero ci sono o non ci sono. Si pensi per es. ai nomi delle stelle, che per lungo tempo hanno costituito un valido e affidabile strumento per chi si trovava in viaggio. Si pensi che alcune delle stelle visibili nell’emisfero nord non sono affatto avvistabili nell’emisfero sud, e questo ha condizionato la necessità di dare un nome (ed eventualmente di riconnettervi racconti fantastici) soltanto a quelle visibili. Per es. per gli antichi greci la costellazione dell’Orsa maggiore, sempre visibile nel corso dell’anno, rappresentava Callisto, la ninfa consacrata a Diana e cui Giove aveva usato violenza[20]. Ma le varianti di tale racconto sono condizionate dalla forma che assume la costellazione nei nostri cieli boreali. Il fatto che essa non tramonti per es. è spiegato nel mondo latino in questo modo: “Teti, moglie di Oceano, non l’accoglie quando le altre stelle giungono al tramonto e questo perché Teti fu nutrice di Giunone a cui Callisto dovette sottostare in quanto rivale in amore”[21], in quanto Callisto aveva suscitato la gelosia furiosa della consorte di Giove. Ma se cambiamo area geografica, cambiano anche i racconti: “[p]er gli aztechi, questa costellazione è il dio Tezcaltlipoca, cupa divinità associata alla morte e al nord, e a cui un mostro celeste ha divorato un piede. Infatti, se alla nostra latitudine l’Orsa Maggiore non tramonta mai, negli altopiani messicani, dove vivevano gli aztechi, l’ultima stella dell’Orsa scompare dietro l’orizzonte”[22]. Questo tratto originariamente fenomenologico del nominare la realtà circostante appare poi evidente quando si vogliano nominare i colori. Per es. gli eschimesi posseggono nella loro lingua diversi nomi per dire una tonalità di colore che noi italiani, all’interno della nostra lingua, qualificheremmo tout court come “bianco” senza neppure porci il problema di una gradazione fra le varie sfumature di questo non-colore[23]. Ciò è motivato naturalmente dalla peculiare configurazione geografica del luogo in cui quel popolo vive. Per fare un altro esempio più antico, possiamo ricordare come nel tentativo di spiegare l’origine del nome della costellazione di Orione alcuni facciano riferimento al termine “urione” che deriverebbe dal verbo greco o÷reîn = orinare, in quanto tale costellazione è (e ciò da millenni) portatrice di piogge sia al suo sorgere che al suo tramontare[24]. Ancora per quanto riguarda questa costellazione, il racconto che Orione sarebbe morto punto da uno scorpione[25] è la trasposizione in parole di ciò che può vedersi nei cieli delle terre che si affacciano sul Mediterraneo, quando la stella Riegel, raffigurante il piede di Orione, tramonta proprio nel momento in cui a est si leva la costellazione dello Scorpione.
Dunque in questo senso ulteriore la lingua è punto di vista sul mondo, e la sua relatività è condizionata anche dalla localizzazione territoriale in cui essa sorge come lingua di un gruppo sociale. Questo ha due conseguenze: innanzitutto, che lo spostamento di un gruppo, identificato da una certa lingua, in un territorio radicalmente diverso, per caratteristiche climatiche, geofisiche, culturali ecc. (insomma: ambientali in senso lato), rispetto a quello d’origine, implica necessariamente l’esigenza di un amalgama fra elementi propri ed elementi estranei, la necessità di un radicamento, che per quanto lento (si pensi ai secoli che sono serviti a smussare le differenze fra i popoli “barbarici” e popoli italici, una volta venuti stabilmente a contatto dopo le invasioni di epoca romana imperiale), per quanto travagliato, è inevitabile e si riflette sulle trasformazioni linguistiche, proprio perché trova il proprio fondamento nel bisogno di nominare una realtà diversa da quella d’origine. È proprio la lingua anzi la cartina di tornasole che rivela l’inevitabilità di questo processo[26].
[...]
[1] Possono darsi confini alle possibilità espressive di una lingua? Possono forse porsi limiti alle possibilità combinatorie dei vocaboli che la costituiscono? E quand’anche si volesse considerare la lingua come somma dei vocaboli che la identificano (cosa che forse può valere per le lingue cd. “morte”, ma ben più difficilmente per le lingue “vive”), dunque come consistente di un numero di parole “finite”, quelle contenute nel dizionario, quali delimitazioni certe possono essere stabilite guardando alla lingua nel suo sviluppo diacronico? E quali “quantità” di vocaboli possono mai essere accertate come formanti una lingua sul piano sincronico? Suoni espressivi come “zzz” o come “ssh”, sono da annoverarsi fra ciò che è parte della lingua? Riflesso dell’imbarazzo che può porre questa domanda è la circostanza che essi siano riportati in N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, XII ed., Zanichelli, Bologna, 1994 (rispettivamente alla voce “zzz” e “st”), ma che non compaiano in Dizionario Garzanti della lingua italiana, Garzanti, Milano, 1965.
Nonostante questa indeterminatezza di confini, sia nell’ordine del tempo, sia nella mole delle parole che compongono una lingua, sappiamo tuttavia dire in maniera intuitiva e al contempo corretta che per es. la parola “notte” è parte della nostra lingua italiana e che la parola “aòslghvwpirut” invece non ne fa parte.
[2] Si pensi per es. al carattere tipografico e alla relativa dimensione con cui può essere sottolineato l’aspetto comunicativo di una singola lettera, la lettera “p” maiuscola: “P”, oppure “P”, o ancora “P”, o invece P. Nel mondo traboccante di segni in cui siamo immersi, la prima P, dalla forma chiara e perentoria, può ricordare i segnali stradali che consentono il parcheggio; la P, tracciata con il carattere tipografico papyrus ci fa pensare all’iscrizione di un locale sulla spiaggia, l’estro della sua forma ci rimanda a qualcosa di istintuale, di non allineato con l’oggettività della scrittura a stampa, la quale invece è regolare, senza svolazzi e lascia procedere il pensiero concettuale senza sviamenti sul versante accattivante della forma grafica delle varie lettere. Infine, la P riprodotta nel carattere Script MT Bold, ci fa fa venire in mente le lettere panciute dei bambini di scuola elementare che noi stessi siamo stati.
[3] In primo luogo mi viene in mente a tale riguardo la riflessione di V. Kandinsky, Punkt und Linie zu Fläche, Albert Langen, München, 1926, tr. it. a cura di M. Calasso, Punto linea superficie. Contributo all’analisi degli elementi pittorici, Adelphi, Milano 1991, p. 17 ss. dove in particolare l’autore in modo ancor più originario che sulle varietà possibili di rappresentazione grafica delle parole, si sofferma sulla risonanza di un semplice, banale punto, il quale può assumere una sonorità addirittura frastornante se tracciato in grandi dimensioni rispetto al formato della pagina. Ma cfr. anche la diversa resa grafica (che possiede una incidenza dal punto di vista del significante), delle parole in questi due esempi a confronto:
Marco e Laura annunciano il loro matrimonio
, che sa di notizia riportata su un quotidiano di provincia o su un foglio parrocchiale,
Rispetto a:
Marco e Laura
annunciano il loro matrimonio
. In questo secondo caso il carattere grafico conferisce maggiore solennità all’evento. Dove abbiamo già visto una forma grafica del genere? Essa ci appare come diretta estrapolazione da una raffinata partecipazione stampata su pergamena, e ciò in quanto il carattere simil-“inglese” rimanda a una forma (per noi italiani addirittura percepita come straniera, dunque dotata del fascino dell’estraneo) che si connota per il richiamo a uno stile che sa di passato solido, che si incardina lungo i binari certi della tradizione, del sostegno che deriva dalla salda famiglia d’origine di cui da decenni si perpetua il modo di fare e lo stile.
[4] Cfr. per es. l’espressione “etwas wie ein Kleinod hüten“ (in Duden, Deutsches Universalwörterbuch, V ed., Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2003, alla voce Kleinod).
[5] Cfr. la voce Kleinod in Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache, Brockhaus, Mannheim, 1997.
[6] Ivi. Cfr. anche l’etimologia della voce Öde ivi.
[7] Cfr. la voce Kleinod in Duden, Herkunftswörterbuch, cit. In A. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache, 18° ed., Walter De Gruyter, Berlin, 1960, alla voce Kleinod si riconduce tuttavia il morfema – od della parola in questione al significato di possesso (Besitz), attestato in antico sassone; secondo Kluge questo significato si sarebbe poi imposto come predominante ad accentuare il valore economico dell’oggetto prezioso.
[8] Cfr. la voce gioiello in Dizionario Garzanti della lingua italiana, cit.
[9] Dal latino cum + capio, che rende conto dell’origine del termine corrispondente in altre lingue occidentali di origine o contaminazione neolatina (cfr. inglese: concept, francese: concept, spagnolo: concepto, portoghese: conceito; ma cfr. anche il corrispondente termine tedesco Begriff, che pur mostrando tutt’altra storia etimologica, lascia trasparire la propria ascendenza diretta dal verbo greifen, afferrare: cfr. Duden, Herkunftswörterbuch, cit., alla voce greifen). Qualcosa del genere, pensata come passaggio dall’indeterminato al determinato, è stata osservata riguardo alla parola greca λόγος, grosso modo corrispondente al nostro “concetto” (cfr. il saggio dal titolo Logos, in M. Heidegger, Vorträge und Aufsätze, Günter Neske, Pfullingen, 1954, tr. it. a cura di G. Vattimo, Saggi e discorsi, Mursia, Milano, 1976, pp. 141-157, spec. p. 142 ss.; nonché M. Heidegger, Der Satz vom Grund, Günter Neske, Pfullingen, 1954, tr. di G. Gurisatti e F. Volpi, a cura di F. Volpi, Il principio di ragione, Adelphi, Milano, 1991, p. 180 ss.).
[10] Cfr. la voce enoteca in Dizionario Garzanti, cit.
[11] Cfr. anche M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, Klostermann, Frankfurt am Main, 1954, tr. it. a cura di U. Galimberti, Sull’essenza della verità, Editrice La Scuola, Brescia, 1973, p. 33 ss.
[12] Dalla raccolta Lichtzwang, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, in P. Celan, Poesie, a cura di G. Bevilacqua, Mondadori, Milano, 1998, p. 982 (“Abbatti i/ puntelli di luce:/ la parola che nuota/ la detiene il crepuscolo”, tr. mia).
[13] Cfr. la voce Dämmer in Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, nella versione digitalizzata su CD-Rom e realizzata dall’Università di Trier, Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 2004. Assai difficile rendere in italiano il gioco linguistico fra questi due significati di Dämmer, tanto più se si considera che si tratta di due termini in disuso per la stessa lingua tedesca contemporanea. In Dämmer risuonano al contempo il crepuscolo, l’argine, il domatore, quindi qualcosa che tiene, o meglio, contiene, argina la parola che si muove qui e lì, scorrendo lungo qualcosa di indifferenziato e dilagante come l’acqua, nuotando nel flusso del darsi degli enti. Per questo motivo, nella traduzione proposta abbiamo reso “hat” con “detiene”, quasi che esso fosse un nodo che congiunge l’aggirarsi nuotante della parola fra gli enti, l’argine che è il crepuscolo che la sostiene, ne opera il contenimento e al contempo l’ammansisce. Nel significato di “detenere” si rinviene infatti al contempo il concetto del possesso (del verbo haben), del dominio che viene esercitato sull’ente su cui si esercita la detenzione e quello di raro, antiquato di arginare (cfr. la voce detenere in Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, cit.), che in tal modo fa il verso al desueto Dämmer.
[14] Lo stesso inconscio, concepito dalla dottrina psicanalitica come sede originaria del linguaggio, ovvero organizzato come un linguaggio (cfr. J. Lacan, Symbole et langage comme structure et limite du champ psychanalytique, in La Psychanalyse, vol. I, Travaux des années 1953-1956, Presses universitaires de Frances, Paris, 1956, pp. 111-133, spec. p. 114 ss.) almeno nella sua dimensione più autentica, scaturigine da cui derivano spinte verso la ripetizione nevrotica, così come l’impulso dotato di forza creatrice, è concepito come qualcosa il cui fondamento resta celato nei recessi bui della psiche proprio per proteggerne l’integrità, di cui il tratto manifesto è l’aspetto coscienziale più lucente: cfr. S. Freud, Das Ich und das Es, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig, Wien, Zürich, 1923, ed. it. a cura di C.L. Musatti, L’Io e l’Es, in S. Freud, Opere, vol. 9, L’Io e l’Es e altri scritti (1917-1923), Bollati Boringhieri, Torino, 1989, pp. 471-520, spec. a p. 477 ss.
[15] Ciò da cui appunto deriva la differenza fra le lingue.
[16] Cfr. Michele Zarrillo, Una rosa blu, dall’album Le occasioni dell’amore, S4, 2002.
[17] Edouard Manet, Rose in un vaso di vetro, collezione privata; l’immagine è riprodotta al sito http://www.fakemaster.it/MAN3.jpg.
[18] Cfr. M. Heidegger, Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte “Probleme” der “Logik”, Klostermann, Frankfurt am Main, 1984, tr. it. a cura di U.M. Ugazio, Domande fondamentali della filosofia. Selezione di “problemi” della “logica”, Mursia, Milano, 1990, p. 49 ss.
[19] Senz’altro la globalizzazione, intesa nel senso più ampio, ha contribuito a smussare le differenze fra le lingue, e per conseguenza fra le culture, i sistemi economici, politici ecc., per cui in certi settori linguistici vi è una tendenza quanto meno all’uniformazione lessicale. Questo processo di uniformazione riceve una spinta costante a livello capillare mediante la proposizione di programmi televisivi e spot pubblicitari più o meno rigidamente codificati, che diffondono un certo tipo di linguaggio che tende a conformare quello delle masse popolari. Ma anche la rete è importante vettore di nuovo lessico da questo punto di vista. Termini come mail, blog, forum, file, facebook, pdf, link ecc. sono ormai internazionalmente conosciuti da tutti coloro che sanno usare il computer e non trovano adeguati antagonisti da parte dei puristi delle lingue nazionali (con tutto che per es. in Francia fatica ad affermarsi il termine “computer” in luogo del quale si dice ordinateur).
[20] Per le varie versioni del mito di Callisto cfr. Caio Giulio Hygino, Poeticon Astronomicon, tr. it. dal latino a cura di B. e D. Piermattei, Fabulario delle stelle, Sellerio, Palermo, 1996, p. 25 ss.
[21] Hygino, Fabulario delle stelle, cit., p. 27.
[22] Così J.-P. Verdet, Le ciel ordre et désordre, Gallimard, Paris, 1987, tr. it. a cura di L. De Tommasi, Il cielo. Caos e armonia del mondo, Electa/Gallimard, Trieste, 1993, p. 32.
[23] Cfr. M. Pastoreau, L’uomo e il colore, inserto al mensile Storia e dossier, n. 5, marzo 1987, Giunti, Firenze, 1987, p. 12.
[24] Cfr. R. Graves, Greek Myths (1955), tr. it. a cura di E. Morpurgo, I miti greci, Longanesi, Milano, 1983, § 41, p. 138, n. 5.
[25] Cfr. R. Graves, I miti greci, cit., § 41, p. 137, n. 3.
[26] Senza risalire ai secoli bui della storia romana tardoimperiale o della storia altomedievale d’Europa, durante i quali si è prodotta la differenziazione delle lingue neolatine, tutte sorte da un’influenza profonda della koiné latina (tant’è che durante il medioevo in territorio italiano si parlava una lingua che era definita “volgare”), questo fenomeno può toccarsi con mano ancora oggi. Per es. la lingua che si parla nelle ex-colonie francesi dell’Africa non è il francese dei puristi propugnato dall’ Académie française. È poi per una ragione del tutto analoga che l’inglese degli Stati Uniti non coincide né per forma sonora, né per tesoro lessicale, con quello britannico da cui esso ha tratto derivazione storica, e un discorso analogo vale per l’inglese come consolidatosi nelle ex-colonie britanniche in Asia o in Africa. È inoltre per questa ragione macroscopica che un progetto politico come il pangermanesimo ha in sé qualcosa di totalmente irrealistico, in quanto la pretesa purezza della razza ariana e della lingua e cultura tedesche alla cui diffusione e imposizione era orientato il piano hilteriano non potrebbero mai mantenere questa assoluta purezza, che sarebbe costantemente insediata dalla necessità di orientarsi in un nuovo contesto ambientale e geografico-climatico oggetto della politica di espansione e di conquista. L’esigenza di avere a che fare con il nuovo ambiente sgretolerebbe prima o poi, necessariamente, anche se questo dovesse avvenire con grande lentezza, i caratteri “puri” e “autentici” della lingua d’origine. Vero è che sia la tecnologia, sia l’urbanizzazione capillare cui è sottoposto il territorio, soprattutto quello attorno ai grandi insediamenti di città, si sovrappongono come una rete di nodi indifferenziati che impediscono di “vedere” l’ambiente – lato sensu – intorno a sé, anzi, sembrano proprio mirare a questo effetto, almeno come conseguenza ulteriore dell’utilità immediata dell’aggregazione urbana. Ciononostante non è materialmente possibile l’eliminazione di questo fondamento differenziato e determinato che è il territorio in cui – se non altro in virtù della forza di gravità! – siamo costretti a radicarci.
- Quote paper
- Giuliana Scotto (Author), 2009, Sul maschile e femminile alla luce dei generi della lingua tedesca, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130611
Publish now - it's free




















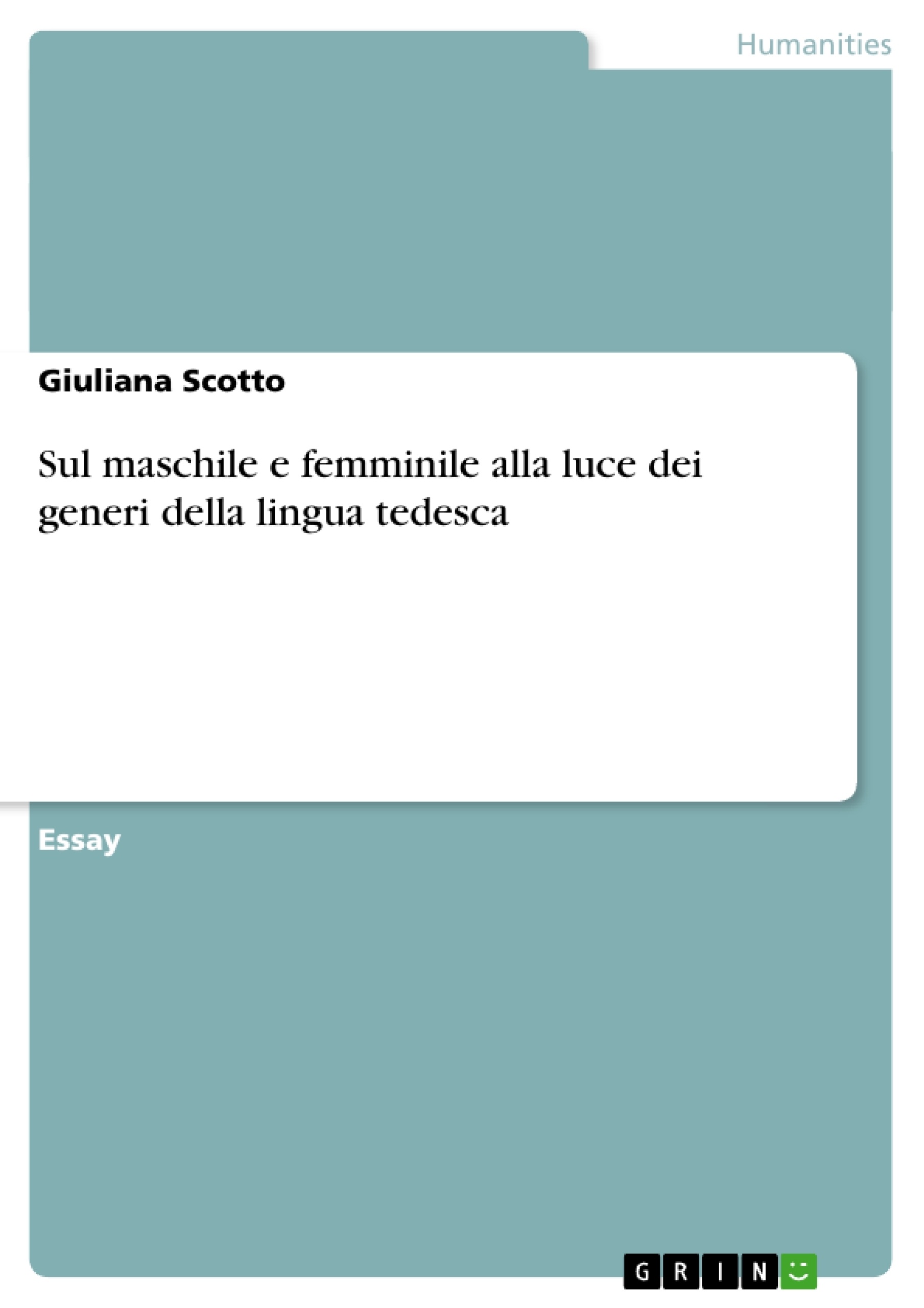

Comments